Uno sotto l’altro in un unico post, “Dagon” di Lovecraft, Miller da “Tropico del Cancro”, Gadda da “La cognizione del dolore”, “Una relazione per un’accademia” di Kafka, “Il nuotatore” di Cheever: racconti e passaggi cruciali di capolavori da leggere o rileggere ad agosto, in attesa della ripresa a settembre.

Howard Philip Lovecraft
DAGON
Scrivo queste note in una morsa d’angoscia e so che al termine della notte sarò finito. Senza un soldo e senza la droga che rende sopportabile la mia esistenza, non posso reggere oltre la tortura: mi butterò dalla finestra di questa soffitta. Ma la mia dedizione alla morfina non deve farvi pensare che sia un debole o un degenerato; quando leggerete queste pagine intuirete (anche se non riuscirete a comprendere del tutto) perché non mi restino che l’oblio o la morte.
Fu in una delle zone più aperte e meno frequentate del Pacifico che il piroscafo di cui ero sovrintendente cadde vittima dell’incrociatore tedesco. La grande guerra era all’inizio e le forze navali del nemico non avevano ancora ceduto completamente, come poi sarebbe avvenuto: la nostra nave venne catturata e noi dell’equipaggio fummo trattati con il rispetto e la considerazione dovuti ai prigionieri di guerra. Anzi, la disciplina dei nostri catturatori era così blanda che dopo cinque giorni riuscii a fuggire da solo, in barca, con acqua e provviste per diverso tempo.
Finalmente libero e alla deriva, non avevo alcuna idea delle acque in cui mi trovavo. Non sono mai stato un provetto navigatore e dalla posizione del sole e delle stelle potei solo concludere che ero a sud dell’equatore, ignoravo completamente la longitudine e non erano in vista né isole né traccia di costa. Il tempo si manteneva buono e per innumerevoli giorni avanzai senza meta sotto il sole feroce, aspettando di scorgere una nave o di essere scagliato sulle sponde di una terra abitabile. Ma non si vedevano né navi né terra, e nell’immensa solitudine del mare e del cielo cominciai a disperare.
Poi, mentre dormivo, avvenne il cambiamento. Non ne conoscerò mai i particolari, perché non mi svegliai dal mio sonno agitato e fitto di sogni. Quando riaprii gli occhi scoprii di essere mezzo sprofondato in una massa disgustosa di fango nero che s’estendeva intorno a me a perdita d’occhio, e in cui la mia barca si era arenata a qualche metro di distanza.
È logico supporre che davanti a una così radicale modificazione del paesaggio la meraviglia fosse il mio stato d’animo predominante, ma in realtà ero più atterrito che sorpreso, perché in quell’aria e in quel fango putrescente c’era una qualità sinistra che metteva l’anima a dura prova. La regione pullulava di carcasse di pesci marciti e di cose meno facilmente descrivibili, che spuntavano un po’ dovunque dal fango dell’interminabile pianura; ma è assurdo sperare di trasmettere, a parole, l’orrore che gravava su quel deserto di assoluto silenzio e sconfinata vastità. Non si sentiva e non si vedeva nulla a parte l’immensa distesa di fango nero: e proprio la totale immobilità e omogeneità del paesaggio mi davano un senso di paura schiacciante.
Il sole bruciava da un cielo in cui non c’era traccia di nuvole e che sembrava nero, come se riflettesse la palude color inchiostro che si stendeva ai miei piedi. Mentre strisciavo verso la barca in secca riflettei che una sola teoria poteva spiegare la mia situazione: in seguito a un fenomeno vulcanico di inaudite proporzioni una parte del fondo oceanico doveva essere venuta a galla, esponendo regioni che per milioni d’anni erano rimaste coperte da incalcolabili quantità d’acqua. L’estensione della nuova regione era tale che, per quanto tendessi le orecchie, non sentivo nemmeno in lontananza il rumore dell’oceano e non c’erano gabbiani a banchettare sui resti di pesce.
Per diverse ore rimasi nella barca a pensare o rimuginare: inclinata su un fianco com’era, col passare del tempo cominciò a offrirmi un po’ d’ombra; il suolo sotto di me sembrò perdere una parte della sua mollezza e si asciugò quel tanto che bastava a coprire brevi tragitti a piedi. Quella notte dormii poco e il giorno seguente feci un pacco che conteneva cibo e acqua e che avrei portato con me in un viaggio d’esplorazione, alla ricerca dell’oceano scomparso e di eventuali soccorsi.
Il terzo giorno il suolo si era asciugato abbastanza per camminarci con facilità. L’odore di pesce era insopportabile ma io, oppresso da pensieri molto più gravi, non mi preoccupai di un male così trascurabile e mi incamminai coraggiosamente verso una meta sconosciuta. Per tutto il giorno avanzai regolarmente verso ovest, usando come punto di riferimento un’altura che si ergeva più di qualsiasi altro oggetto sul deserto ondulato. Di notte feci un piccolo campo e il giorno dopo ripresi ad avanzare verso l’altura, che non sembrava più vicina della prima volta che l’avevo vista. La quarta sera arrivai alla base dell’elevazione, molto più alta di quanto apparisse in lontananza; una valle la separava dal resto della pianura, dandole
ancora maggior risalto. Troppo stanco per tentare un’ascesa, mi addormentai ai suoi piedi.
Non so perché i miei sogni, quella notte, fossero tanto strani, ma prima che la falce di luna calante si levasse dall’orizzonte orientale ero sveglio, in un bagno di sudore freddo e decisissimo a non addormentarmi più. Non me la sentivo di sopportare oltre le cose che avevo visto in sogno, e al chiarore della luna mi resi conto che ero stato uno sciocco a viaggiare di giorno. Senza il calore e il riflesso accecante del sole il viaggio mi avrebbe stancato molto meno: anzi, ora mi sentivo pronto a compiere la scalata che al tramonto mi aveva trattenuto. Raccolsi il pacco delle provviste e mi incamminai verso il vertice dell’altura.
Ho detto che l’assoluta monotonia della pianura era per me una fonte di terrore, ma credo di aver provato una paura anche più forte quando raggiunsi la vetta e guardai nell’incommensurabile gola, o baratro, che si stendeva dall’altro versante. Era così terribile che la luna, ancora relativamente bassa nel cielo, non riusciva a illuminarne il fondo. Mi parve di essere sull’orlo del mondo e di guardare oltre il bordo, in un abisso incommensurabile di notte e caos; e nel terrore ebbi una strana reminiscenza del Paradiso perduto, l’orrenda scalata di Satana negli sconosciuti regni delle tenebre.
Man mano che la luna s’alzava nel cielo mi resi conto che i fianchi della gola non erano perpendicolari come avevo immaginato: costoni e sporgenze improvvise offrivano un buon appiglio per la discesa e dopo un precipizio di qualche centinaio di metri il declivio si faceva graduale. Spinto da un impulso che non riesco ad analizzare, mi calai con difficoltà per il primo tratto e arrivai nel punto in cui la discesa si faceva più dolce. Poi guardai il baratro in cui la luce non era mai entrata.
Improvvisamente la mia attenzione fu catturata da un grande e singolare oggetto che si trovava sul fianco opposto della gola, il quale s’innalzava ripidamente a un centinaio di metri da me. Colpito dalla luna che ormai era sufficientemente alta, l’oggetto brillava di bianco. Che fosse soltanto un obelisco di pietra, è un fatto di cui mi accertai presto: ma giunsi alla conclusione che la sua forma e la sua posizione non potevano essere opera della natura. Esaminandolo più da vicino provai sensazioni che non è facile descrivere, perché, nonostante la sua immensa grandezza e la sua collocazione in un baratro che l’oceano aveva sommerso fin dall’alba del mondo, dava la sensazione di essere stato costruito, e forse adorato, da creature intelligenti.
Stupito e terrorizzato, ma non privo di un pizzico d’esultanza scientifica
e archeologica, decisi di esaminare più attentamente l’ambiente in cui mi trovavo. La luna, vicina ora allo zenit, splendeva con fantastica chiarezza sui gradini giganteschi che sprofondavano nel burrone, e mi permise di scoprire che sul fondo c’era un corso d’acqua. Il torrente si perdeva verso sbocchi invisibili in entrambe le direzioni, ma mentre ero sul declivio mi lambiva quasi i piedi. Al di là del baratro gli spruzzi raggiungevano la base del monolito ciclopico, sulla cui superficie distinguevo sia iscrizioni che rozze sculture. La scrittura si basava su un sistema di geroglifici a me sconosciuto e diverso da tutti quelli che avevo visti nei libri: consisteva, perlopiù, di simboli acquatici stilizzati come pesci, anguille, polipi, crostacei, molluschi, balene e simili. Alcuni ideogrammi riproducevano animali marini sconosciuti al mondo moderno, ma le cui forme decomposte avevo visto sulla pianura.
Furono le sculture, comunque, a impressionarmi di più. Ben visibili, per la loro mole ciclopica, anche al di qua dell’abisso, formavano una sequenza di bassorilievi il cui tema avrebbe fatto l’invidia di un Doré. Credo che nelle intenzioni degli scultori le figure dovessero rappresentare uomini, o almeno una specie particolare di uomini, che tuttavia nuotavano come pesci nelle profondità di grotte sottomarine e pregavano davanti a un altare di pietra pure sommerso. Non oso descrivere nei particolari i loro corpi, i loro volti, perché il semplice ricordo mi fa star male. Grotteschi oltre l’immaginazione di un Poe o di un Bulwer-Lytton, nell’insieme erano maledettamente umani ma avevano mani e piedi palmati, labbra enormi e mollicce, occhi vitrei e sporgenti e altri tratti ancora più spiacevoli. Cosa alquanto strana, sembravano sproporzionati rispetto allo sfondo: una delle creature era rappresentata nell’atto di uccidere una balena che era poco più grande di lei. Fui colpito, come ho detto, dalle loro dimensioni e dall’aspetto grottesco, ma un attimo dopo decisi che doveva trattarsi semplicemente degli dèi fantastici di una primitiva popolazione di pescatori o marinai; una popolazione, peraltro, i cui ultimi discendenti erano morti milioni d’anni prima che nascesse l’antenato dell’uomo di Neanderthal o di Piltdown. Intimorito dalle prospettive che si aprivano su un passato inconcepibile anche per l’antropologo più fantasioso, continuai a rimuginare sotto la luna che gettava strani riflessi nel canale ai miei piedi.
Poi, all’improvviso, lo vidi. L’essere affiorò dall’acqua nera con un solo risucchio: vasto, ciclopico e disgustoso sfrecciò verso l’obelisco come un meraviglioso mostro d’incubo, poi abbracciò la stele con le enormi braccia scagliose e piegò la testa, emettendo una serie di suoni misurati. Credo di essere impazzito allora.
Della mia frenetica risalita sul pendio della gola e il fianco dell’altura ricordo ben poco, come pure del viaggio di ritorno alla barca. Credo di aver cantato a squarciagola e di aver riso come un pazzo quando non riuscivo a cantare. Ho confusi ricordi di un violento temporale, scoppiato poco dopo aver raggiunta la barca; comunque, so di aver sentito scoppi di tuono e altri boati che la natura emette quando è nella sua fase più violenta.
Quando emersi dalle ombre ero in un ospedale di San Francisco, dove mi aveva lasciato il comandante della nave americana che mi aveva raccolto in mezzo all’oceano, a bordo della mia barca. In delirio avevo raccontato quasi tutto ciò che avevo visto, ma alle mie parole era stata prestata scarsa attenzione. I miei salvatori non erano al corrente di fenomeni geologici o emersioni di terre nel Pacifico e io non ritenni necessario insistere su una storia che non avrebbero potuto credere. Una volta sola ho cercato un etnologo, un famoso scienziato, divertendolo con le mie strane domande sull’antica leggenda filistea di Dagon, il dio-pesce; poi, resomi conto che era legato a punti di vista quanto mai convenzionali, ho lasciato perdere.
È di notte, specialmente quando la luna è bianca e calante, che lo rivedo; ho tentato la morfina, ma la droga mi ha dato una liberazione solo temporanea e in compenso mi ha fatto schiavo. Dopo aver scritto questo resoconto, che costituirà lo spasso dei miei simili, sento che è ora di finirla. Spesso mi chiedo se tutta l’avventura non possa esser stata un’allucinazione, un attacco di febbre sopravvenuto quando, in realtà, me ne stavo sul fondo della barca e deliravo nel sole, dopo la fuga dall’unità tedesca. Questo mi domando: ma ogni volta, in risposta, vedo una scena raccapricciante e vivida come non mai. Non posso pensare al mare profondo senza rabbrividire all’idea degli esseri che forse, in questo stesso momento, si trascinano e guizzano sul fondo melmoso, intenti nell’adorazione degli antichi ..doli di pietra e nell’arte di scolpire le loro detestabili fisionomie su obelischi sommersi di granito. Sogno il giorno in cui usciranno dai flutti e stringeranno negli artigli immensi i resti dell’umanità insignificante, logorata dalle guerre… il giorno in cui le terre sprofonderanno e il fondo oscuro dell’oceano salirà in superficie, nel pandemonio universale.
La fine è vicina. Sento un rumore alla porta, come se un immenso corpo viscido vi premesse contro. Non mi troverà. Dio, quella mano! La finestra! La finestra!
(Dagon, luglio 1917)
* * *

Henry Miller
da TROPICO DEL CANCRO
“La vita”, dice Emerson, “è fatta di ciò che l’uomo pensa tutto il giorno.” Se è così, allora la mia vita non è altro che un enorme intestino. Tutto il giorno non penso ad altro che al cibo; e non solo: me lo sogno di notte.
Tuttavia, non chiedo di tornare in America, di essere torchiato a doppia vite, di girare il bindolo. No, preferisco essere un pover’uomo in Europa. Dio sa se sono povero; mi resta solo da diventare un uomo. La settimana scorsa ho pensato che il problema del vivere fosse pressoché risolto, ho pensato di essere ormai autosufficiente. È successo che ho incontrato un altro russo, di nome Serge. Abita a Suresnes, dove c’è una colonia di émigrés e di artisti scalcagnati. Prima della rivoluzione, Serge era capitano della Guardia Imperiale; a piedi nudi misura un metro e novanta e beve vodka come un pesce. Suo padre era ammiraglio, o qualcosa del genere, sulla corazzata Potemkin.
Ho conosciuto Serge in circostanze singolari. Giravo col naso all’odore del cibo quando mi sono trovato, l’altro ieri a mezzogiorno, nei pressi delle Folies Bergère: all’entrata di servizio, cioè il vicoletto con il cancello di ferro in fondo. Ciondolavo vicino all’ingresso del palcoscenico, sperando vagamente di incontrare per caso una delle farfalle, quando si accosta al marciapiede un camion scoperto. Vedendomi lì con le mani in tasca, l’autista, che era Serge, mi chiede se voglio dargli una mano a scaricare i bidoni di ferro. Quando sente che sono americano e che sono a terra, quasi si mette a piangere dalla gioia. È tanto tempo che cerca un maestro d’inglese, pare. Lo aiuto a rotolare i fusti di insetticida fin dentro il teatro e guardo finché ne ho voglia le farfalle che volteggiano nelle quinte. Quel fatto per me assume proporzioni straordinarie: la casa vuota, le bambole di segatura che saltellano nelle quinte, i fusti di disinfettante, la corazzata Potemkin; ma soprattutto la cortesia di Serge. È grosso ma tenero, uomo da capo a piedi, ma col cuore di una donna.
Nei caffè vicini – Café des Artistes – mi propone immediatamente di accogliermi a casa sua; dice che metterà un materasso sul pavimento dell’androne. Per le lezioni, dice che mi darà un pasto al giorno, un pasto abbondante, russo, e se per qualsiasi motivo il pasto dovesse mancare, cinque franchi. A me sembra meraviglioso: meraviglioso. C’è solo un problema, come farò ad andare ogni giorno da Suresnes all’American Express?
Serge vuole assolutamente che cominciamo subito: mi dà i soldi per il viaggio a Suresnes in serata. Ci arrivo poco prima di cena, col mio sacco, per dare lezione a Serge. Già ci sono altri ospiti: pare che sempre mangino così, a gruppi, mettendo ciascuno la sua parte.
Siamo otto a tavola; e tre cani. I cani mangiano prima. Mangiano fiocchi d’avena. Poi cominciamo noi. Anche noi fiocchi d’avena, come antipasto. “Chez nous”, dice Serge, con l’occhio che gli luccica, “c’est pour les chiens, les Quaker Oats. Ici pour le gentleman ça va.” Dopo i fiocchi, minestra di funghi e verdure; poi frittata con pancetta, frutta, vino rosso, vodka, caffè, sigarette. Niente male, questo pasto alla russa. Tutti parlano a bocca piena. Verso la fine del pasto, la moglie di Serge, che è una sudiciona armena, pelandrona, piomba sul divano e comincia a rosicchiare bonbon. Pesca nella scatola con i ditoni grassi, ne morde un pezzettino per vedere se dentro c’è liquore, e poi lo butta ai cani.
Finito il pasto, gli altri corrono via. Corrono via a precipizio, come se avessero paura della pestilenza. Serge e io restiamo coi cani; sua moglie si è addormentata sul divano. Serge girella distratto, raccattando i rifiuti per i cani. “Ai cani piace molto” dice. “Molto buono per i cani. Il piccolo cane ha vermi… troppo giovane ancora.” Si china a esaminare certi vermi bianchi sul tappeto, fra le zampe del cane. Cerca di spiegarmi in inglese la storia dei vermi, ma il suo vocabolario è un po’ scarso. Alla fine va a prendere il dizionario. “Ah” dice, guardandomi esultante, “tapeworms.” A quanto pare la mia reazione non è molto intelligente. Serge rimane perplesso. Si china sul pavimento, mani e ginocchia, per esaminarli meglio. Ne prende uno e lo mette sul tavolo accanto alla frutta. “Uh, non molto grande” borbotta. “Alla prossima lezione tu insegnare vermi, no? Tu molto bravo maestro. Io fare progressi con te…”
Disteso sul materasso, nell’androne, l’odore del disinfettante mi soffoca. Un odore pungente, acido, sembra invadere ogni poro della mia pelle. Il cibo comincia a tornarmi in gola, i fiocchi d’avena, i funghi, il prosciutto, le mele fritte. Vedo la piccola tenia vicino alla frutta e tutte le varietà di vermi che Serge ha messo sulla tovaglia per spiegarmi il male del cane. Vedo la platea vuota delle Folies Bergère e in ogni crepa ci sono scarafaggi, pidocchi e cimici; vedo gente che si gratta freneticamente, si gratta e si gratta finché non le esce il sangue. Vedo i vermi che strisciano sullo scenario come un esercito di formiche rosse, divorando tutto quel che vedono. Vedo ballerine che gettano via le tuniche di garza e nude fuggono giù per la platea, tra le file delle poltrone; vedo spettatori in platea che buttano via i vestiti, anche loro, e si grattano l’un con l’altro come scimmie.
Cerco di calmarmi. Dopotutto, questa che ho trovato è una casa, e c’è un pasto che mi attende ogni sera. E Serge è un brav’uomo senza dubbio. Ma non riesco a dormire. È come mettersi a dormire in un obitorio. Il materasso è saturo di liquido da imbalsamazione. È un obitorio di pidocchi, cimici, scarafaggi, tenie. Non ce la faccio. Non ce la voglio fare. Dopotutto sono un uomo, non un pidocchio.
La mattina aspetto che Serge carichi il camion. Gli chiedo di portarmi a Parigi. Non ho il coraggio di dirgli che me ne vado. Lascio in casa il sacco con le poche cose che mi restano. Quando arriviamo a place Pereire, salto giù. Non c’è un motivo speciale per scendere qui. Sono libero, ecco l’importante.
Leggero come un uccello, vago da un quartiere all’altro. È come se mi avessero dimesso dalla prigione. Guardo il mondo con occhi nuovi. Ogni cosa mi interessa profondamente. Anche le quisquilie. In rue du Faubourg Poissonnière mi fermo davanti alla vetrina di un istituto di cultura fisica. Ci sono fotografie che mostrano campioni di virilità, “prima e dopo”. Tutti mangiatori di rane. Alcuni sono nudi, a parte il pince-nez o la barba. Non capisco come tipi simili si diano alle parallele o ai manubri. Un mangiatore di rane dovrebbe avere un pochettino di pancia, come il barone de Charlus. Portare la barba e il pince-nez va bene, ma mai farsi fotografare nudo. Dovrebbe mettersi scarpe lucide di vera pelle. Nel taschino della giacca a sacco dovrebbe esserci un fazzoletto bianco che sporge di due centimetri. Possibilmente un nastrino rosso al bavero, passato per l’occhiello. Prima di andare a letto dovrebbe mettersi il pigiama.
Verso sera, avvicinandomi a place Clichy, incontro la piccola puttana con la gamba di legno; tutti i giorni se ne sta davanti al cinema Gaumont. Non dimostra più di diciotto anni. Ha i suoi clienti abituali, immagino. Dopo mezzanotte sta lì con il suo arnese nero piantato per terra. Dietro di lei c’è il vicoletto che fiammeggia come un inferno. Passandole accanto, a cuor leggero, ricorda, chissà come, un’oca legata alla staccionata, un’oca malata di fegato perché il mondo possa avere il suo pâté de foie gras. Dev’essere strano portarsi a letto la gamba di legno. Si immagina di tutto, schegge ecc…
Giù per rue des Dames mi imbatto in Peckover, altro povero diavolo che lavora al giornale. Si lagna perché la notte dorme soltanto tre o quattro ore: si deve alzare alle otto del mattino perché lavora nel gabinetto di un dentista. Non lo fa per denaro, mi spiega, ma per comprarsi una dentiera. “È dura leggere le bozze quando crolli dal sonno” dice. La moglie, quella crede che sia un posto sicuro. “Che facciamo se perdi quel posto?” dice. Ma a Peckover non importa nulla del lavoro. A lui non rimane neppure qualche spicciolo. Deve mettere da parte le cicche e fumarle nella pipa. Il vestito gli sta su a forza di spilli. Ha il fiato greve e le mani sudate. E di notte, soltanto tre ore di sonno. “Non è la maniera di trattare un uomo” dice. “E quel padrone, mi fa cacare sangue se sbaglio un punto e virgola.” Parlando della moglie aggiunge: “Quella donna, cazzo, non ha gratitudine per me, te lo dico io!”.
Quando lo lascio riesco a scroccargli un franco e cinquanta. Cerco di portargli via altri cinquanta centesimi, ma è impossibile. Comunque, quanto basta per un caffè e contorno di croissant. Presso la Gare St. Lazare c’è un bar a prezzi ribassati.
Fortuna vuole che nel lavabo io trovi un biglietto per il concerto. Leggero come una piuma, ora vado alla Salle Gaveau. La maschera sembra turbata perché trascuro di dargli la mancia. Ogni volta che mi ripassa accanto mi guarda con aria inquisitoria, come se magari all’improvviso io dovessi ricordarmene.
È parecchio tempo che non siedo in compagnia di gente ben vestita, quasi mi viene il panico. Sento ancora odore di formaldeide. Forse Serge consegna insetticida anche qui. Ma nessuno si gratta, grazie a Dio. Lieve odore di profumo… molto lieve. Anche prima che cominci la musica c’è quello sguardo annoiato sul viso della gente. Per un attimo, quando il direttore d’orchestra batte la bacchettina, c’è un intenso spasimo di concentrazione seguito, quasi immediatamente, da un collasso generale, una specie di abbandono quasi vegetale, indotto dal continuo, ininterrotto piovigginio dell’orchestra…
* * *

Carlo Emilio Gadda
da LA COGNIZIONE DEL DOLORE
Dietro domanda del medico elencò le sue sofferenze recenti, le solite. Il medico dondolò il capo e disse di volerlo visitare. Salirono al piano delle camere, lui avanti. Entrarono in una camera grande a pareti scialbate di giallino, con due finestre, di cui una chiara, aperta sulle robinie, sulle cicale, e due letti. I monti del settentrione. Quasi nero, a travi ed assi, il soffitto: verniciato con l’olio di lino in una tinta affumata, com’era l’uso di Spagna, un tempo.
Il figlio si liberò della giacca, si sdraiò sul letto più interno, il suo: di coltre bianchissima, come l’altro, di pesante noce: tantoché il tarlo vi si udiva cigolare a fatica, con un giro duro e breve, di cavatappi, dopo stanchi intervalli. Su quel candore conventuale il lungo corpo e la eminenza del ventre diedero una figurazione di ingegnere-capo decentemente defunto, non fossero stati il colorito del volto, e anche lo sguardo e il respiro, a prevalere sulla immobilità greve della testa; che affondò un poco nel cuscino, bianco e rigonfio, tutto svoli. Subito la linda frescura di quello nobilitò la fronte, i capegli, il naso: si sarebbe pensato ad una maschera, da dover consegnare alle gipsoteche della posterità. Era invece la faccia dell’unico Pirobutirro maschio vivente che guardava alle travi del soffitto. Orizzontale sul bianco.
Le due scarpe a punta, lucide, nerissime, parvero due peperoni neri, per quanto capovolti, puntuti. Movendo nelle àsole e nelle bretelle mani bianche, lunghe, il morto si preparava all’auscultazione. Dalla parete di fronte, tra le finestre, da una cornice di noce, la guardata corusca del generale Pastrufacio, in dagherrotipo. Vigeva a mezzo busto nella penombra, con il poncho, e due cocche alla spalla manca d’un fazzolettone sudamericano: e in capo quel suo berretto, tra familiare e dogale, cilindrico; torno torno esornato d’alcuni fregi di fil d’oro, in disegno di cirri, rare ghiande, viticchi. La bionda capellatura dell’eroe, schiaritasi molti anni avanti nel bagno di fissaggio, scendévagli armoniosa alle spalle e quivi giunta si ripigliava dolcemente in una rotolatura nobilissima, da parer fatto d’Andrea Mantegna o Giovanbellino: come d’un paggio degli Este o dei Montefeltro venuto alle pampe, e agli anni di bandiera e di schioppo. Trascesa la cinquantina, tutte le gote e il disotto dei labbri s’infoltivano d’una generosità maschia del pelo, d’un vigore popolano ed antico: incrudito alla vastità delle guerre e superfluente dalle cornici dei ritratti.
La visita fu «coscienziosa». Il dottore palpò l’ingegnere a lungo, e anche a due mani, come a strizzarne fuori le budella: pareva una lavandaia inferocita sui panni, alla riva d’un goriello; poi, mollate le trippe, l’ascoltò un po’ per tutto, saltellando in qua e in là, con il capo e cioè con l’orecchio, pungendolo e vellicandolo con la barba. Poi gli mise lo stetoscopio sul cuore e sugli apici: per gli apici, sia davanti che dietro. Alternò l’auscultazione con la percussione digitale e digito-digitale, tanto i bronchi e i polmoni che, di nuovo, il ventre. Gli diceva: «si volti»: e di nuovo: «si rivolti». Nell’ascoltarlo dalla schiena quando era seduto sul letto e tutto inchinato in avanti, con il gonfio e le pieghe del ventre in mezzo ai femori, a crepapancia, e tra i ginocchi la faccia, la camicia arrovesciata al di sopra il capo come da un colpo di vento, oppure sdraiato bocconi, mezzo di sbieco, mutande e pantaloni senza più nesso, allora il dottore aveva l’aria di comunicargli per telefono i suoi desiderata; gli fece dire parecchie volte trentatré, trentatré; ancora trentatré. All’enunciare il qual numero l’ingegnere si prestò di buona grazia, col viso tra i ginocchi.
Con questo, la visita ebbe termine.
Dalla finestra aperta la luce della campagna; screziata di quella infinita crepidine.
Il malato si ricomponeva, sceso dal letto; la sua figura inutile si riprendeva da un oltraggio non motivato nelle cose; il dottore, con un tono un po’ mortificato, gli confessò che non riscontrava nulla di preoccupante: scosse il capo: nulla, assolutamente nulla. Prescrisse dei dadi di Sedobrol, dissoluti ognuno in una tazza d’acqua tepida, un paio di volte al giorno, lontano dai pasti. Acqua tepida… Già, proprio… Acqua, acqua. S’impazientì perché l’ingegnere gli fece un paio di domande come uno scemo; o era forse distratto. In una tazza da tè… ma già, già, naturale… ma sicuro… per modo da cavarne un bel brodino… sì, insomma… una tazza di brodo. Il bismuto, se credesse, poteva anche lasciarlo.
E le cicale, popolo dell’immenso di fuori, padrone della luce.
Il figlio ringraziò del suggerimento. Prese di mano del dottore il fogliolino col recipe, vi lesse in una guardata il poco scritto e l’intestazione col numero del telefono, lo depose sulla tavola ch’era di là dai letti, alla prima finestra; lo fermò con un piccolo poliedro terso, di cristallo molato, tutto luci. Pareva non aver dato alcuna importanza alla constatazione del medico né, oramai, alla cerimonia che l’aveva preceduta: anzi, al chiudere il giustacuore, d’essersi dimenticato del male. «Le mal physique», in questo caso: il male visibile.
C’era tuttavia un qualchecos’altro: gli occhi si rattristarono ancora, a poco a poco mutò d’espressione, come al rinascere d’un pensiero doloroso che fosse momentaneamente sopito; in tutto il volto gli si leggeva uno sgomento, un’angoscia, che il medico tra sé e sé non esitò un minuto ad ascrivere «a una nuova crisi di sfiducia nella vita»: e anche, certo, certo, «ai postumi della disfunzione gastrica che lo aveva tanto disturbato l’altr’anno». Da tempo, del resto, conosceva le mutazioni repentine di quell’aspetto e di tutto il contegno del cliente. Gli occhi parevano desiderare e nello stesso tempo respingere ogni parola di conforto. Una opacità imperscrutabile e, si sarebbe detto, una ottusità generale del sensorio facevano la nota di quiescenza in quella fisionomia senza rilievo: poi, tutt’a un tratto, i rilievi e addirittura le prominenze sgradevoli. Lo sguardo si accendeva in una perspicacia velata di timidezza, in una sorta di prontezza bambinesca, la parola si animava per subito dopo arenarsi, come di uno sopraffatto subitamente, alle concioni del prossimo. Talvolta il rigore della inquisizione assumeva toni brevi, asciutti, severi, da riuscir temibili ove li avesse avvalorati una superiorità pragmatica quale che fosse, l’odio, la ricchezza, il potere, l’ufficio.
In quel momento gli occhi parvero significare la certezza della povertà, guardare con dignità disperata la solitudine. Il medico e padre, tuttavia, persisteva nell’opinione che anche un naufrago, a voler davvero, lo si può ripescar fuori dai flutti, dalla ululante notte: il tessuto sociale interviene allora al soccorso: e agisce contro la cianosi del singolo col vigore non mai spento della carità; opera come una respirazione d’artificio, che ridona al prostrato, dopo il soffio azzurro della speranza, il rosso calore della vita. Il cliente taceva. Credette pertanto di venirgli incontro con l’arrischiare un invito, e lo fece con quel suo piglio un po’ burbero e ciò nondimeno cordiale: lodò, così, sporgendo il capo un momento fuor di finestra, la stagione e il paese: «… delle giornate come queste!… ma guardi!… è un delitto sciuparle… come fa lei». Lodò di nuovo i monti, alcuni dei quali nominò. Poi le acque. Poi il clima e le frescure del Serruchón, zeffiri e balsami. Poi dalla salubrità dell’aria venne su, su, a poco a poco, all’azzurro dei cieli, alla rinnovata asfaltatura delle strade principali, ai Romani d’una volta e alle Chryslers di oggi; finché distrattamente sempre, e così alla meglio, come parlasse tra sé e sé, o tra una nuvola e l’altra, si lasciò andare finalmente a proporgli una gitarella in automobile per l’indomani, con la Giovanna e la Pina.
«Guiderà la mia Pina… La vedesse!… Lo dicon tutti, del resto… ma quella lì la è nata al volante!… Ma, poi… lei la conosce bene la Giuseppina… un diavolo!… Un diavolo con le sottane…».
Il discendente maschio di Gonzalo Pirobutirro d’Eltino non batté ciglio: guardava al di là delle cose, dei mobili: un accoramento inspiegabile gli teneva il volto e anzi quasi la persona. Come quelli che vi hanno un fratello o un figlio: e li veggono fumare, fumare, i vertici dell’Alpe senza ritorni, fioriti di cùmuli, in un rombo lontano. Il tarlo cavatappi non desisteva dal suo progresso; dopo l’accumulo d’ogni intervallo precipitava alla commemorazione di sé.
«Così solo, a leggere: o, peggio ancora, a scrivere! Ma cosa diavolo legge, poi!… Cosa scrive?… Le sue memorie?… Ma quelle aspetti un po’ a scriverle quando avrà novant’anni!.… In questi giorni! In questi posti!… Ma si goda l’aria, la luce. Muoversi, muoversi… andare… ubriacarsi d’aria, anche lei, come tutti… guardi un po’ gli altri come se la sanno prendere con filosofia… il Borella… il Tabacchi… il Pedroni…».
Erano degli immigrati recenti e peritissimi coltivatori di lattuga; di razza indubbiamente àriana, se si vuol giudicare dai nomi. L’amplesso della villa, ognun la sua beninteso, li aveva condotti a quella forma d’anestesia irreversibile, per quanto rubiconda e confortata di sèdani, ch’è uno dei più felici portati della villeggiatura serruchonese.
Da vespero a mattutino un cane senza museruola gli latrava nei più felici dei loro sonni, mentreché la vigilanza notturna accudiva a vigilare dal di fuori.
«Ma non vede? che giornate? che sole?… Vada, vada!… E impari anche lei a guidare… che la Pina le può dar lezione… un diavolo simile… Vedrà, vedrà…».
«Lo credo, dottore, e la ringrazio», obiettò cerimoniosamente il tipo: «ma domattina devo esser di nuovo… cioè… potrei partire alle undici…». La voce gli smorì a metà cammino, tra la strozza e i labbri. Allegò vari impegni che lo avrebbero distolto per la dimane stessa alla pace della villa, (immersa in quella salamoia di cicale e di luce), e sottratto, con suo indicibile rammarico, a una tanto auspicata gita «con le sue signorine». Disse anche, quasi a colmare la giustificazione, che si sentiva veramente mortificato di non saper guidare. Fu mettere il piede in una buca. La stupidità di quel proposito, dopo il suggerimento paterno delle lezioni di guida, sarebbe apparsa lampante a qualunque altro, meno distratto o meno impacciato di lui.
«… Ma se le ripeto che c’è la mia Pina… sì, sì… la Giuseppina… Lei la conosce, no?… ma se le ha parlato tante volte!…». Il figlio Pirobutirro ebbe l’aria di navigar nel vago: confondeva facilmente le Giovanne con le Giuseppine, e anche con le Teresine: ma più che tutto, a terrorizzarlo, era l’insalata delle Marie e Marie proclitiche, cioè le Mary, le May, le Marie Pie, le Anne Marie, le Marise, le Luise Marie e le Marie Terese, tanto più quando le riscopriva sorelle, a cinque a cinque, da doverle discriminare lì per lì nella baraonda dei rinfreschi, dopo schematiche presentazioni. «… Insomma, le dico che non importa», continuò il dottore; «lei starà seduto come un papa; davanti, magari, dove ha meno scosse… a guardare il paesaggio… ad assaporarlo in tutta la sua dolcezza… E la Pina guiderà. Non si fida della mia Pina?».
O! certo! Egli si fidava pienamente della «signorina Giuseppina», (Quell’astrazione onomàstica non gli dava modo di raccapezzarsi). Ringraziò nuovamente; calorosamente. «… Ma non è possibile…». Emise un sospiro. Era molto preoccupato. Quasi seccato. Fu molto cortese. Un senso di noia, di irritazione era nel suo sangue: un’ansia indicibile sul giro del gàstrico, dov’è il duodeno, come piombo: una figurazione di colpa, di inadempienza, nel suo contegno. Nel suo occhio oramai stanco, velato, si adunarono cose dolorose, lontane. Troppo lontane da quel discorso.
Intanto, dopo dodici enormi tocchi, le campane del mezzogiorno avevano messo nei colli, di là dai tègoli e dal fumare dei camini, il pieno frastuono della gloria. Dodici gocce, come di bronzo immane, celeste, eran seguitate a cadere una via l’altra, indeprecabili, sul lustro fogliame del banzavóis: anche se inavvertite al groviglio dell’aspide, molle, terrore maculato di tabacco. Vincendo robinie e cicale, e carpini, e tutto, le matrici del suono si buttarono alla propaganda di sé, tutt’a un tratto: che dirompeva nella cecità infinita della luce. Lo stridere delle bestie di luce venne sommerso in una propagazione di onde di bronzo: irraggiàrono la campagna del sole, il disperato andare delle strade, le grandi, verdi foglie, laboratori infiniti della clorofilla: cinquecento lire di onde, di onde! cinquecento, cinquecento!, basta basta, signor Francisco, ma questo qui non fa male… di onde, di onde! dalla torre: dal campanile color calza, artefice di quel baccano tridentino. Furibonda sicìnnide, offerivano il viscerame o poi lo rivoltavano contro monte, a onde, tumulto del Signore materiato, baccanti androgìne alla lubido municipalistica d’ogni incanutito offerente. Arrovesciate nella stoltezza e nella impudicizia, esibivano alternamente i batocchi, come pistilli pazzi, pesi, o per la fame del povero la inanità incaparbita della cervice: e la ruota, a fianco ogniduna, intricava il disegno: ed erano i convòlvoli del Bronzo Enorme, cui arrovesciasse bufera di demenza. Ebbre di suono altalenarono un pezzo ad evacuare la gloria; gloria! gloria! di cui eran satolle: a spandere in ogni campo quella annunciazione clamorosa, d’un po’ di puchero. E di chiquoréa tritata, condita con l’olio di linosa.
I due uscivano dalla camera. Il dottore non parve arrendersi: «… noi, in ogni modo, l’aspettiamo…»: puntò sull’estremo valore di quella indicazione, sull’ipostàsi del fatto compiuto: «… lei, poi, si regoli come crede…»: e il tono stavolta fu il tono dimesso dell’uomo giusto, del debole che non può contrastare al sopruso. «Domattina alle sette, sette e un quarto… partenza!». Ma l’ora con l’oro in bocca finì d’esasperare quel malato indietreggiante che ogni più cordiale annuncio di felicità pareva mettere in un inspiegabile allarme.
«… Sette e mezzo al più tardi… quando il Seegrún è ancora nelle ombre… Vedesse!… E lo potrà constatare anche lei, finalmente, se la Pina la sa guidare… sì o no… e in che modo la guida!…».
Presero a discendere le scale, adagio, il dottore avanti. Sostava ad ogni gradino, senza rivolgersi, quasi monologando: «si può dire che la conoscon tutti, su tutte le strade del Serruchón!… Da Iglesia giù giù fino al Prado: da Novokomi a Terepáttola. Un fulmine! Basta vederla arrivare. 0 magari anche di lontano, come la infila una curva: con che disinvoltura, con che eleganza!… che si dice subito: è lei!».
Pochi giorni avanti, sullo stradone di Iglesia, la signorina Giuseppina aveva appena infilata (a motore spento) la curva del chilometro nove, quando si trovò il Recalcati tra i fanali, per non dire tra i piedi: un alpigiano d’Iglesuela che discendeva ai mercati con delle formaggelle e passava per essere un uomo di carattere, come gli alpigiani in genere. Difatti, con la gerla vuota in ispalla, e all’incontro d’un autotreno di sacchi di cemento, le dimezzò di colpo quella scivolata così fluida che doveva deporla senza bruciare un centesimo alle prime case del Prado.
Costretta a una soluzione di fortuna, la ragazza, secondo il solito, l’affrontò con lucidità magistrale. E dopo il sacrificio della frenata (e il cuore tàccolo tàccolo fino giù in fondo alle calze) le rimase però fiato bastevole per dargli ancora una spintarella, al Recalcati, con l’aiuto del parafango, ma così garbata, così calibrata, che collocò senz’altro il suo carattere e la sua gerla al di là della cunetta, contro il muro di Villa Giuseppina, giusti giusti. L’omonimìa le menò buono. Il forte figlio della montagna, sentito il sapore del muro, sentito il medico, (un altro dal papà, naturalmente), sentito il pretore, videro subito tutti e tre che non c’era materia – no hubo elemento – per ripetere «ni un centavo di danni»: né da lei, Higueróa Giuseppina di Felipe y Carlotta Morelli, né dal señior Bertoloni, il gerente responsabile di Villa Giuseppina.
«… Muy bien, la muchacha… muy bien… muy bien…», rimuginò il figlio tra sé e sé, a denti stretti, nel riandar l’avvenuto: come cincischiasse uno stecco. Il medico dové avere un qualche sospetto: «… L’altra settimana… giovedì 22… di certo lo avrà sentito anche lei… perché un’ora dopo lo sapevan tutti… potevano essere giusto le cinque, cinque e mezza… dopo il chilometro dell’osteria, dopo la pergola, ha in mente? è la curva peggiore di tutto l’arrondimiento… dov’è anche la portineria dei Bertoloni… beh, dica un po’ se non ha salvato la vita al Recalcati… sa, quello dei formaggini…». Il figlio dové concedere ai formaggini di entrare anche loro nel cerchio doloroso della appercezione. Era il bagaglio del mondo, del fenomènico mondo. L’evolversi di una consecuzione che si sdipana ricca, dal tempo: tra i fasti del campanone sottoscritto, oblato: (da òbfero, òbtuli). E le cose narrate dal tempo e dalle anime frànano giù nella evidenza del giorno, dal loro limbo sciocco: come da piena cornucopia cataratta maravigliosa di pomi, spaccarelle, fichi secchi.
Li sistemò come poté, i formaggini, in quel campo oltraggioso di non-forme: in quel caravanserraglio d’impedimenti d’ogni maniera: cicale cipolle zòccoli, bronzi ebefrènici, Giuseppi paleo-celtici, Battistine fedeli lungo i decenni, gozzocretine dalla nàscita: tutto l’acheronte della mala suerte brodolato giù dal senno e dal presagio dei padri, che vi leggevano ilari, giulivi, in quel fiume di catrame, la cara normalità della contingenza, la ingenuità salubre del costume villereccio.
E rivide in un suo giolito la bella scena rurale della gerla e del parafango, bel sogno d’arazzo: d’un Luigi quindici un po’ ammodernato: «Les quatre saisons. L’été». Tutto falci, tutto gerle, tutto messi, tutto vacche, tutto villici: e la Giuseppina che gli arriva addosso in volata. Oh! quella così misurata e ragionevole accelerazione inferta – via deretani – al passo moroso della cocciutaggine!
Ma tutto, del tempo, gli diveniva stanchezza, stupidità.
La chiacchiera non aveva l’aria di coagulare. «Del resto le mie ragazze potrebbero darle qualche lezione di guida. Chi non sa guidare, oggigiorno?… Perfino la zia del Manoel Torre ha imparato, la vecchia! E come la galoppa!… che la vedo scendere al Prado tutti i sabati, al mercato, appena han bisogno di piselli, di pomidoro… Son sicuro che alla terza o quarta se la caverebbe anche lei magnificamente…»: alzò le spalle: «… non le sembra?». Poi abbassò la voce come a farlo partecipe d’un segreto: «… con la sua intelligenza… con tutta la meccanica che ha in testa…».
L’idea delle lezioni non era malvagia, povero dottore. «E creda: si divertirebbe… Che vuole? caro signor Gonzalo, a quell’età… hanno l’argento vivo addosso…». Anche l’argento vivo fu accolto dal figlio con un sorriso: eran sorrisi brevi, circostanziati, che non facevano fare un passo avanti al discorso. Giunti al ripiano delle scale, che fungeva da anticamera, presero a stropicciare le scarpe sull’ammattonato, tutti e due, come volessero saggiare il mattone: il medico ripigliò il bastoncello, che aveva lasciato in un canto.
Uscirono sul terrazzo da cui si guardava l’estate, a mezzogiorno e a ponente. Le campane tacevano: le cicale gremivano l’immensità, la luce. Un senso di puchero deglutito in famiglia era succeduto al metallo accomunante della liturgia. Il terrazzo è a livello del piccolo giardino dietro casa, con il quale comunicava direttamente, dopo il solo ostacolo dun gradino di serizzo. Questo giardino triangolare, e un po’ orto, di minima estensione, con le cipolle e la vigna, e il fico, tutto frescure ed ombre il mattino, permetteva a chiunque di passare in casa dal di dietro, sospingendo il cancelletto in ferro pitturato di verde, dal quale era entrato e stava ora per uscire il dottore. La casa si squadrava bianca alla costa, e anzi al sommo, verso mezzogiorno, in corrispondenza dell’ultima ripa: che faceva un dislivello di metri 4,25: l’altezza d’un piano. Sul davanti, contro il sole, c’era un piano di più.
Dal terrazzo la veduta spaziava perdutamente fino alle lontane colline, e poi più lontano forse, nel sole. Si spegneva ai tardi orizzonti: e agli ultimi fumi delle fabbriche, appena distinguibili nella foschia: posava alle ville e ai parchi, cespi verdissimi, antichi, tutt’attorno la mite e famigliare accomàndita di quei piccoli laghi.
Eran livelli celesti, opachi, future torbiere, tra l’insorgere dei mille piacevoli incidenti d’una orografia serena, che aveva conosciuto il cammino delle Grazie. Terra vestita d’agosto, v’erano sparsi i nomi, i paesi. Ed era terra di gente e di popolo, vestita di lavoro.
Tanto il dottore che il figlio sostarono, si fecero al parapetto, chiamati da quella significazione di vita. Tutto doveva continuare a svolgersi, e adempiersi: tutte le opere. Il domani dalle bocchette d’oriente affacciàndosi con dorati cigli avrebbe ritrovato le cose: come il fabbro dove lo ha lasciato nella fucina, ivi si ripiglia il martello. Insaccato nelle spalle, intento a guardare, il figlio aveva le due mani alla balaustra di legno, le braccia divaricate ed aperte, come stanche ali. Guardava dolorosamente. «… Mia madre è invecchiata…», disse. Poi con violenza: «… Sono anni… sono disperato…». Pronunciò queste ultime parole come in un sogno: e l’ora da una torre lontana sembrò significare: «gli atti sono tutti adempiuti». Una anticipazione straordinaria, come una beffa crudele, precipitava giù sui pollai estracomunali quella sequenza bugiarda: ma non molto, non molto! e sarebbe scoccata l’ora vera, la verità grave: il decreto inappellabile di Lukones. Si ritrasse. Il medico lo guardò. Aveva ora le mani congiunte sotto il ventre, come sogliono tenerle i monaci, le dita tra le dita, quasi pregasse, bianche, lunghe, un po’ ingrossate alle nocchie: inesperte, era chiaro, d’ogni meccanica, o motore, o pompa, o sporca fatica. Il viso triste, un po’ bambinesco, con occhi velati e pieni di tristezza, col naso prominente e carnoso come d’un animale di fuorivia (che fosse tra il canguro e il tapiro), si rivolse di là dal muretto di cinta verso la montagna, e l’azzurro oltremonte: forse, di là, i cieli e gli eremi, e nulla. La madre, tornando dal cimitero, avrebbe dovuto apparire da dietro il canto della casa, col vecchio ombrellino che le serviva ad appoggiarsi: la mamma! Dopo aver disceso i gradini al piccolo cancello da cui entravano tutti, senza chiedere; curva, forse la sorreggeva la donna, per un braccio, che non mettesse il piede a inciampare. Dopo aver percorso adagio il vialetto lungo il muro, dimessamente, annunciandosi col cri cri lieve, sgretolato dei tardi passi. «… Non capisco che cosa m’è venuto in mente… Ho protestato con lei perché non c’erano fiori sulla tomba…. e allora ha voluto andar lei… con queste strade!». Si portò fino all’angolo della casa: guardava angosciato alla straducola che discendeva dalle ville più alte, che la mamma avrebbe dovuto percorrere, un ciòttolo dopo l’altro, tornando dal cimitero… Rivenne sul terrazzo. «… Glie l’avevo detto perché lo dicesse lei a José, al suo caro José, al peone… all’adorato concittadino di cui paghiamo le tasse… a cui paghiamo…»: il medico, a capo chino, si frustò col bastoncello il polpaccio destro: «… la luce… l’alloggio… la legna… l’inchiostro… come di diritto… perché si degni di zoccolar per casa con le più lerce brache che gli riesce d’infilare… Due piantine di geranio, via, su quella tomba!… ma dice che non attecchiscono… E la mamma c’è voluta andar lei, allora, per paura ch’io gridi…».
Un passo facile, d’una corsa leggera e spensierata, e il rapido franare del ghiaietto dopo che il cancello aveva cigolato inopinatamente li avvertì che arrivava qualcuno, di certo un ragazzo. Da dietro il cantone della casa un ragazzo se ne venne correndo, sudato; di colpo, allo scorgere i due uomini, arrestò quella corsa, in un’attitudine un po’ contrariata, quasi avesse veduto sfumare i cioccolatini. Con una maglia caffè, un quaderno tra mano, le gambe tutte nude. I ginocchi, pieni d’ammaccature e di tagli, erano la cosa principale dopo la fanciullaggine d’un viso rotondo, imperlato dal sudore. Ansimava leggermente, come una locomotiva che seguiti a soffiare anche dopo ferma, nonostante la presenza dei ministri. Era un bimbo sano, dal torace color caffè, d’un dodici anni all’incirca, dagli occhi vuoti d’ogni criterio: tutto il mondo, per lui, doveva essere una specie di pera acerba, dove non poteva mettere i denti. La sua anima senza sillabe testimoniava dell’anamnèsi. Ora taceva, guardando, ritto e fermo, con quelle gambe: «Che vuoi?», gli gridò malamente il figlio, come spazientito dal silenzio. Quello, senza farsi innanzi, balbettò di lontano qualchecosa come la lezione, íl francese,… la Signora. «Vattene!» imperò il figlio. Con una severità inconcepibile, che lo fece sparire: e lasciò interdetto il medico.
«… Ma non è il nipotino del Di Pascuale? », dimandò questi.
«… Non so chi sia, né di chi sia nipote… Quel che so è che mia madre è rimbambita… come tutti i vecchi…»: parlò concitatamente. Il dottore si batteva il polpaccio con la bacchetta. «… che ha bisogno di bavare bontà sul primo vitello che le càpita tra i piedi… sul primo cane randagio che viene a oltre… Anche i nipoti dei colonnelli in vacanza, adesso… da fargli ripetere choux, bijoux, cailloux, poveri tesori… Perché si diventa buoni, buoni!». Gridava. Pareva ammattire. «Buoni, buoni!… si diventa… Fino a che i gerani, le màmmole, ci premiano della nostra buona condotta… della nostra bontà definitiva…».
«è un fior d’un medico…» arrischiò il dottore con quel suo discorso un po’ brontolato, fatto perennemente a capo chino, quasi un monologo «… e, credo, un funzionario integerrimo…»: poveraccio, sembrava recitare un «a parte» nel teatro dei nobili.
«Non è una ragione per tirarsi in casa tutta la sua conigliera di nipoti!… Il francese che se lo impàrino a scuola… che è fatta apposta… E se non lo impàrano», guardò fisso il dottore: «se non lo impàrano,… szàc!». Fece l’atto del frustar le gambe a un qualcuno, a un cavallo?; che ne avesse di lunghe, nude, diritte. Mise il capo in orizzontale ad accompagnare il sussulto della spalla, il gesto impetuoso del braccio, come avesse davvero a mano la frusta. Un’ira incredibile alterò la sua fisionomia incoerente. «E non lo imparano… e non lo impareranno mai!… perché i vitelli non parlano idioma… Stentano a scrivere due proposizioni in castellano.… E allora szàc, szàc, szàc!… sulle gambe nude… Ecco che arriva la carità, la bontà!…». Urlava. «Le lezioni di francese, arrivano! In coppa ai vitelli… A gratis. Sull’orlo della fossa… per gli altri…! per il peone… per il nipotino… qualunque cosa, pur che sia per gli altri… per gli altri!».
Il medico taceva, confuso: vergognandosi di quel mezzo centimetro di barba, si sarebbe detto: in realtà meravigliato, addolorato. Senza poter giustificare in alcun modo ciò che udiva, ciò che vedeva, capì tuttavia che un qualcosa di orrido stava ribollendo in quell’anima. Pensò di incanalare altrove le idee del malato, se idee eran quelle.
Il figlio si ricompose: parve ridestarsi da un’allucinazione: lo guardò: lo fissava come gli domandasse, a lui, «che cosa ho detto?», come implorasse «mi dica che cosa ho detto!… Stavo male! non ha veduto? Non ha veduto che stavo male?… Perché non ha voluto credermi, non ha voluto soccorrermi?… Avevo smarrito il discorso… che cosa dicevamo…». I suoi occhi rinvennero a una espressione di angoscia. Un passo correva di fuori, discendendo, d’uno stupido folletto; sotto cui franavano i sassi della stradaccia, dopo il cigolio del cancello, ch’era pitturato di verde.
«… Sono stato un bimbo anch’io…», disse il figlio. «… Allora forse valevo un pensiero buono… una carezza no; era troppo condiscendere… era troppo!», e l’ira gli tornava nel volto, ma si spense. Poi riprese: «… La mamma è spaventosamente invecchiata… è malata… forse sono stato io… Non so darmi pace… Ma ho avuto un sogno spaventoso…».
«Un sogno?… e che le fa un sogno?… è uno smarrimento dell’anima… il fantasma di un momento…».
«Non so, dottore: badi… forse è dimenticare, è risolversi! è rifiutare le scleròtiche figurazioni della dialettica, le cose vedute secondo forza…».
«Secondo forza?… che forza?…».
«La forza sistematrice del carattere… questa gloriosa lampada a petrolio che ci fuma di dentro,… e fa il filo, e ci fa neri di bugìe, di dentro,… di bugìe meritorie, grasse, bugiardosissime… e ha la buona opinione per sé, per sé sola… Ma sognare è fiume profondo, che precipita a una lontana sorgiva, ripùllula nel mattino di verità».
Parve incredibile al dottor Higueróa che un uomo di corporatura normale, alta anzi, di condizione socialmente così «elevata», potesse lasciarsi ancorare a delle sciocchezze come quelle. Ma lo sgomento e la tristezza erano troppo evidenti nello sguardo; di persona che teme, che ha un qualcosa che l’occupa, un rimorso; terrore, odio? anche nel sole pieno: nel canto, nella pienezza dolce e distesa della terra.
«… Un sogno… strisciatomi verso il cuore… come insidia di serpe. Nero.
Era notte, forse tarda sera: ma una sera spaventosa, eterna, in cui non era più possibile ricostituire il tempo degli atti possibili, né cancellare la disperazione… né il rimorso; né chiedere perdono di nulla… di nulla! Gli anni erano finiti! In cui si poteva amare nostra madre… carezzarla… oh! aiutarla… Ogni finalità, ogni possibilità, si era impietrata nel buio… Tutte le anime erano lontane come frantumi di mondi; perse all’amore… nella notte… perdute… appesantite dal silenzio, conscie del nostro antico dileggio… esuli senza carità da noi nella disperata notte…
E io ero come ora, qui. Sul terrazzo. Qui, vede?… nella nostra casa deserta, vuotata dalle anime… e nella casa rimaneva qualche cosa di mio, di mio, di serbato… ma era vergogna indicibile alle anime… degli atti, delle ricevute… non ricordavo di che… Le more della legge avevano avuto chiusura… Il tempo era stato consumato! Tutto, nel buio, era impietrata memoria… nozione definita, incancellabile… Delle ricevute… che tutto, tutto era mio! mio!… finalmente… come il rimorso.
E il sogno, un attimo!, si riprese in una figura di tenebra… là!… là, dove sono andato or ora, ha visto? al cantone della casa… Ecco, vede? là… nera, muta, altissima: come rivenuta dal cimitero. Forse, col suo silenzio, arrivava alla gronda: sembrò velo funereo, che ne ricadesse… Forse era al di là d’ogni dimensione, d’ogni tempo…
Non suffusa d’alcuna significazione d’amore, di dolore… Ma nel silenzio. Sotto il cielo di tenebra… Veturia, forse, la madre immobile di Coriolano, velata… Ma non era la madre di Coriolano! oh! il velo non mi ha tolto la mia oscura certezza: non l’ha dissimulata al mio dolore.
Conoscevo, sapevo chi era. Non poteva esser altro… altissima, immobile, velata, nera…
Nulla disse: come se una forza orribile e sopraumana le usasse impedimento ad ogni segno d’amore: era ferma oramai… Era un pensiero… nel catalogo buio dell’eternità… E questa forza nera, ineluttabile… più greve di coperchio di tomba… cadeva su di lei! come cade l’oltraggio che non ha ricostituzione nelle cose… Ed era sorta in me, da me!… E io rimanevo solo. Con gli atti… scritture di ombra… le ricevute… nella casa vuotata delle anime… Ogni mora aveva raggiunto il tempo, il tempo dissolto…».
Le cicale franàrono nella continuità eguale del tempo, dissero la persistenza: andàvano ai confini dell’estate. Il dottor Higueróa sembrava cercar le betulle, bianche virgole nei querceti a tramontana di Lukones.
Seguitava a bacchettarsi il polpaccio destro: con leggeri tocchi stavolta, ripetuti come a inseguire un ritmo, o a cavar la polvere dal pantalone. Il suo sguardo insolitamente orizzontale s’era ancorato al muriccio, e poi vagava di fuori, al monte, con occhi pesi, enfiati, che facevano da mensole al rimirare. Un lieve arrossamento delle congiuntive conferiva a quei due poveri strumenti da condotto di campagna la stanca espressione della fatica: come d’un cane travagliato, tutto il giorno correndo: una misericorde e smarrita dolcezza, la tristezza di chi abbia oramai dimesso ogni fisima d’itinerario, di viaggio: e chieda solo al tempo e alle nùvole di volerlo aiutare, quel po’ di cammino che gli avanza. Il pùngere della barba, nel mento, pareva tener luogo dei cocci di piatto, dei triangoli di bottiglia che mancavano sul displuvio del muro. Era un muro pirobutirrico; senza schegge di bottiglia, né frantumi di piatto.
«… Non so che cosa m’è venuto in mente…», ripeté il figlio: «… non so più che cosa fare… perché non torna, ora?… è spaventosamente invecchiata. La sua faccia, le sue labbra, si direbbe che nascondono un pensiero non suo… che tacciono parole indicibili… ma la lontananza è già in lei… La mia mamma!… è alcune settimane che non la vedevo; come aiutarla ora?… le mani sono scheletrite…». Come ogni giudice taceva, riprese a giustificarsi: «… ho gridato, è vero: ma non per lei… ma per quella canaglia a cui paghiamo le tasse…».
«Ma intanto ha gridato», fece saviamente il dottore: «e ha gridato con lei!… Del resto, se lei crede, la potremo visitare… anche oggi… anche ora…»: professionalmente usava il plurale di maestà: «una visita è poca fatica…».
«Ah!… poca fatica?… Per lei forse, dottore, che c’è avvezzo. Ma la mamma!… Sono anni!… sono arrivato alla disperazione… è issare un cadavere in cima alla torre Eiffel…»: la voce riprese a concitarsi, poi si adagiò nella cupezza: «… una resistenza sorda… immedicabile…». Poi si riempì d’ira, di dileggio: «… il cervello delle donne…, se appena arrivano ad arrivare ai trenta,… è marmo… La loro anima non si muove più. Le tavole del barbone, quello là coi due corni radioattivi che facevano lume agli Ebrei,… le sue tavole… dovevano essere di pasta di semolino, al confronto…».
«… Cercheremo di persuaderla… che vuol che le dica?… Se poi è che non ha fiducia… del sottoscritto, e ha intenzione di sentirne un altro, oeh! ma s’immagini! non sarà la fine del mondo… Niente di male: siamo qui apposta per aiutarci: se non c’è uno, c’è l’altro… La potremo portare a Novokomi dal dottor Balanzas, in macchina, la Pina sarà felice, povera signora!… o dal dottor Oliva, giusto… meglio ancora! 0 anche a Terepáttola, se crede, il professor Lodomez, quello che ha curato il Caçoncellos…»: guardava al muro, al muriccio.
Il figlio dubitò, col volto: «La mamma non ne vorrà sapere, la conosco: non c’è nulla da fare con lei… è una manìa, una vera psicosi… dal tempo che ci ha partorito… forse, chissà, da bimba: quando non poteva soffrire gli occhiali del dottore… e la spaventavano,… con la barba dell’omino cattivo… Forse perché è sempre stata sanissima…
Dice: ringraziamo l’acqua fresca… la miglior medicina è tenersi lontano dai medici…».
«… Non ha tutti i torti, dopo tutto…».
«Va bè: ma oggi?… oggi?… Dice: io sto benone. Basta che mi lasciate in pace… Lasciatemi un po’ in pace!
Bel modo di curarsi!… a dire: io non ho nulla. Io non ho mai avuto bisogno di nessuno!… io, più i dottori stanno alla larga, e meglio mi sento… Io mi riguardo da me, che son sicura di non sbagliare… Io, io, io!».
E di nuovo si lasciava prendere da un’idea, e levò la voce, rabbiosamente: «Ah! il mondo delle idee! che bel mondo!… ah! l’io, io tra i mandorli in fiore… poi tra le pere, e le Battistine, e il Giuseppe!… l’io, l’io!… Il più lurido di tutti i pronomi!…».
Il dottore sorrise della sfuriata, non capì. Colse tuttavia il destro di volgere un po’ al sereno le parole, se non l’umore e i pensieri.
«… E perché diavolo? Che le hanno fatto di male, i pronomi? Quando uno pensa un qualchecosa deve pur dire: io penso… penso che il sole ci passeggia sulla cucùrbita, da destra a sinistra…». (Nel Sud-America, difatti, e nella Canzone di Legnano).
«… I think; già: but I’m ill of thinking…» mormorò il figlio. «… I pronomi! Sono i pidocchi del pensiero. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta, come tutti quelli che hanno i pidocchi… e nelle unghie, allora… ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona…».
Il dottore sbuzzò a ridere suo malgrado, con metà della bocca: con la guancia di sinistra. Come, anche non volerlo, d’un bimbo si finisce a sorridere: quando nel più infernale de’ suoi capricci, nel delirare dalla rabbia, nel pestare i piedi, tra perle di lacrime e strilli fino alle stelle, rugge «va’ via, butto!» a tutti quanti lo vorrebbero calmare con una carezza: e mette in allegria tutti quanti.
L’aforisma, decifrarlo, macché, nemmeno ci pensò: un problema di scacchi, e maggiore delle sue forze.
Si bevve una boccata sana, piena, di quell’aria calda, così pura, fiato di vita. Dilatò sotto il cravattonzolo tutta la gabbia delle còstole e dello sterno, a inspirare: a lasciarsene bruciare i polmoni. Si volse in direzione del Prado, che col suo lustro cupo il fogliame dell’òlea gli celava parzialmente, da destra: le case lontane parevano fumare in quell’oro dell’agosto: ma già i pidocchi, i pronomi pidocchi, anche questa gli toccava di sentire! lui che per dire «mia moglie» diceva «la mia signora»: in castigliano beninteso: mi señora.
«… Il solo fatto che noi seguitiamo a proclamare… io, tu… con le nostre bocche screanzate… con la nostra avarizia di stitici predestinati alla putrescenza… io, tu… questo solo fatto… io, tu… denuncia la bassezza della comune dialettica… e ne certifica della nostra impotenza a predicar nulla di nulla,… dacché ignoriamo… il soggetto di ogni proposizione possibile…».
«… Quale sarebbe?…».
«… è inutile ch’io lo nòmini invano… Quello che ha appena finito di venir fuori di là…», col volto significò la torre, «dalla matrice di quelle mènadi scaravoltate a pancia all’aria… col batacchio per aria… Bestie pazze! per cui ho patito la fame, da bimbo, la fame! Cinquecento pesos! cinquecento: di munificenza pirobutirrica: cinquecento pesos!… con la maglia rattoppata… i geloni ai diti… i piedi bagnati nelle scarpe… i castighi! perché i diti gelati non potevano stringer la penna… col mal di gola sul Fedro… con sei gradi di amor paterno addosso… e un fumo da far inverdire le meningi… perché il caro batacchio venisse buono… buono agli inni e alla gloria… il batacchio… a intronare la cara villa, con le care patate, nel caro Lukones… a romperci i timpani per quarant’anni!… Tolgono la pace ai vivi e ai morti, creda: mi vietano di scrivere: di leggere… financo i Vangeli mi fanno buttar via,… dal baccano che impiantano, dopo due minuti!… tale è il pandemonio che ne dirompe fuori, dalla mattina alla sera… dalle quattro alle undici… Una russia compagna! ma è roba da spararsi…».
Si avviarono a rigirare il cantone della casa, passo passo. Discèsero il gradino di servizio: «… Io, tu: il salumiere ladro esclude il salumiere furfante che ha bottega dirimpetto: va bene che è più ladro di lui: ma via! dal momento che sono due ladroni tutt’e due… Caçoncellos, il Camöens di Terepáttola, diceva che Vergilio è un coglione: perché Palinuro è una bugìa, e i ludi navali una retorica da leccapiatti… Sì,… sta’ fresco!…
… otto anni d’una guerra navale che affamò Roma secondo lui gli parevano un tamarindo al seltz… e Sesto Pompeo una barca da sardelle… Mentre i suoi dimetri terepattolesi erano il mistero, il domani!… Io ho dato espressione immortale ai più moderni ideali del mio popolo! Io sono disceso in fondo alle anime… sì… a Villa Giuseppina!… io, io, anche lui!… dacquava i fiori con un anaffiatoio buco, che glie ne pisciava metà sulle scarpe… E poi, se un’idea è più moderna di un’altra, è segno che non sono immortali né l’una né l’altra…
… Io, tu… Quando l’immensità si coagula, quando la verità si aggrinza in una palandrana… da deputato al Congresso,… io, tu.… in una tirchia e rattrappita persona, quando la giusta ira si appesantisce in una pancia,… nella mia per esempio… che ha per suo fine e destino unico, nell’universo, di insaccare tonnellate di bismuto, a cinque pesos il decagrammo… giù, giù, nel duodeno… bismuto a palate… attendendo… un giorno dopo l’altro, fino alla fine degli anni… Quando l’essere si parzializza, in un sacco, in una lercia trippa, i di cui confini sono più miserabili e più fessi di questo fesso muro pagatasse… che lei me lo scavalca in un salto… quando succede questo bel fatto… allora… è allora che l’io si determina, con la sua brava mònade in coppa, come il càppero sull’acciuga arrotolata sulla fetta di limone sulla costoletta alla viennese… Allora, allora! è allora, proprio, in quel preciso momento, che spunta fuori quello sparagone d’un io… pimpante… eretto… impennacchiato di attributi di ogni maniera… paonazzo, e pennuto, e teso, e turgido… come un tacchino… in una ruota di diplomi ingegnereschi, di titoli cavallereschi… saturo di glorie di famiglia… onusto di chincaglieria e di gusci di arselle come un re negro… oppure», erano arrivati al cantone, abbassò la voce, «… oppure saturnino e alpigiano, con gli occhi incavernati nella diffidenza, con lo sfinctere strozzato dall’avarizia, e rosso dentro l’ombra delle sue lèndini… d’un rosso cupo… da celta inselvato tra le montagne… che teme il pallore di Roma e si atterrisce dei suoi dàttili… militem, ordinem, cardinem, consulem… l’io d’ombra, l’animalesco io delle selve… e bel rosso, bello sudato… l’io, coi piedi sudati… con le ascelle ancora più sudate dei piedi… con l’aria bonna nel c… tra le cipolle e le pere di spalliera… vindice del suo diritto… come quel ladrone là… che è tutta mattina che ha da levar il seme alle cipolle!…». Col mento, le mani in tasca, fece segno verso il peone: il quale ora, un ginocchio nell’erba, lo si vedeva e udiva a raschiare, con un coltellino, il cavo d’un paiolo. Di certo, allo scoccar mezzogiorno aveva intermesso la sua fatica, per preparare il puchero. Il dottore, zitto, aveva lasciato venir giù quella grandinata rabbiosa, senza nemmeno accennare ad aprir bocca: aveva gli occhi tristi, enfiati, a guardar le montagne.
«… Io, io, io!… Ma lo caccerò di casa! Col pacco de’ suoi diritti legato alla coda… fuori, fuori!… a quadrupedare di là dal muro… a zoccolar sui sassi, giù e su da Iglesuela, dond’è piovuto…». Il peone, finalmente, levò il capo e il cappello fuor dal paiolo, ma non arrivava ad intendere. Capì che il discorso non lo riguardava: i signori, spesso, fanno della metafisica.
«… Il muro è gobbo, lo vedo, e anche le anime dei morti lo scavalcherebbero… dei poveri morti! per tornare a dormire nel loro letto… che è lì, bianco… come lo hanno lasciato al partire… e par che li aspetti… dopo tanta guerra!… è storto, tutto gobbe: lo so: ma il suo segno, il suo significato rimane, e agli onesti gli deve valere, alla gente: deve valere. Per forza. Dacché attesta il possesso: il sacrosanto privato privatissimo mio, mio!… mio proprio e particolare possesso… che è possesso delle mie unghie, dieci unghie, delle mie giuste e vere dieci unghie!…» levò le mani dalle tasche e le mise daddovero sotto agli occhi del medico, tutt’e due pari, con dita adunche, come fossero artigli d’un avvoltoio.
«… E quelle dei piedi dove le lascia?…».
«… Dentro, io, nella mia casa, con mia madre: e tutti i Giuseppi e le Battistine e le Pi… le Beppe, tutti i nipoti ciuchi e trombati in francese o in matematica di tutti i colonnelli del Maradagàl… Via, via! fuori!… fuori tutti! Questa è, e deve essere, la mia casa… nel mio silenzio… la mia povera casa…».
* * *

Franz Kafka
UNA RELAZIONE PER UN’ACCADEMIA
Eccellenti signori dell’accademia!
Voi mi fate l’onore di chiedermi per la vostra accademia una relazione sulla mia precedente vita di scimmia.
In questo senso purtroppo non posso adempiere all’invito. Quasi cinque anni mi dividono dalla condizione di scimmia, un tempo forse breve se misurato sul calendario, ma infinitamente lungo da attraversare al galoppo come ho fatto io, a tratti accompagnato da uomini eccellenti, da consigli, consensi e musica d’orchestra, eppure fondamentalmente solo, perché tutto l’accompagnamento si manteneva, per rimanere nell’immagine, lontano dalla barriera. Questo risultato sarebbe stato impossibile se mi fossi ostinato a voler rimanere attaccato alla mia origine e ai miei ricordi di gioventù. Una piena rinuncia a ogni ostinazione è stato il primo comandamento che mi sono imposto; io, che ero una scimmia libera, mi sono adattata a questo giogo. A loro volta, però, i ricordi in questo modo mi si rifiutavano sempre di più. Se in un primo momento il ritorno, quando fosse stato consentito dagli uomini, mi era aperto attraverso un portale alto quanto il cielo sulla terra, in seguito, parallelamente alla mia evoluzione che proseguiva a colpi di frusta, esso divenne sempre più basso e più stretto; nel mondo degli uomini mi sentivo sempre più a mio agio, sempre più compreso; la tempesta che soffiava dal mio passato si calmò; oggi è solo una corrente d’aria che mi rinfresca i calcagni; e quel buco lontano da cui questa corrente viene e attraverso il quale sono passato un tempo è diventato così piccolo che, anche se avessi forza e volontà sufficienti per correre a ritroso fin laggiù, dovrei scorticarmi tutta la pelliccia per passarci attraverso. Parlando chiaramente, benché io preferisca usare delle immagini per simili discorsi, tuttavia parlando chiaramente: la vostra natura di scimmia, signori, per quanto possiate averne una dietro di voi, non può esservi più lontana di quanto la mia lo è da me stesso. Tuttavia, un prurito al calcagno lo sente chiunque cammini sulla terra: il piccolo scimpanzé come il grande Achille.
Nel senso più limitato tuttavia posso rispondere alla vostra domanda, e lo faccio persino con gioia. La prima cosa che ho imparato è stata la stretta di mano; una stretta di mano dimostra franchezza; ora che sono al vertice della mia carriera, possa anche una parola franca raggiungere quella prima stretta di mano. Una tale parola non aggiungerà novità essenziali per l’Accademia, e rimarrà molto al di sotto di ciò che mi si richiedeva, ma deve mostrare quale sia la linea di sviluppo di chi, un tempo scimmia, è riuscito a entrare e a stabilirsi saldamente nella comunità umana. Non potrei tuttavia dire io stesso quel poco che seguirà se non fossi pienamente sicuro di me stesso e se la mia posizione su tutti i palcoscenici di varietà del mondo civilizzato non fosse ormai incrollabile.
Sono nato nella Costa d’Oro. Di questo sono stato informato da estranei dopo la mia cattura. Una spedizione di caccia della ditta Hagenbeck – con la sua guida fra l’altro ho poi vuotato diverse bottiglie di buon vino rosso – si era appostata nei cespugli sulla riva, quando la sera insieme al branco mi avvicinai di corsa per bere. Spararono; io fui l’unico a essere colpito; mi raggiunsero due colpi.
Uno nella guancia; questo era lieve; mi lasciò però una grossa cicatrice rossa spelacchiata, che mi è valsa il nome di Rotpeter, un nome che odio, del tutto inappropriato, che sembra proprio inventato da una scimmia, come se solo questa macchia rossa sulla guancia mi distinguesse da quella scimmia addomesticata che chiamano Peter, crepata di recente, famosa soltanto qua e là. Ma questo, sia detto di sfuggita.
Il secondo colpo mi raggiunse sotto l’anca. Questo era grave, è colpa sua se ancor oggi zoppico un poco. Ultimamente, nel lavoro di uno dei diecimila fanfaroni che straparlano di me sui giornali, ho letto che la mia natura di scimmia non sarebbe ancora del tutto soppressa, e lo dimostrerebbe il fatto che provo piacere a togliermi i pantaloni davanti ai visitatori per mostrare il foro d’entrata di quel colpo. A questo bel tomo bisognerebbe far saltare ogni singolo ditino della mano con cui scrive. Io, io posso togliermi i pantaloni davanti a chi mi pare; là sotto non troveranno altro che una pelliccia ben curata e una cicatrice dovuta a un – scegliamo qui per uno scopo definito una parola definita, che però non vuol essere equivocata – la cicatrice dovuta a un colpo scellerato. Tutto è alla luce del sole; non c’è niente da nascondere; quando un uomo di alti principi si avvicina alla verità mette da parte i modi raffinati. Se invece fosse quel giornalista a calare i pantaloni davanti ai visitatori, la cosa avrebbe un aspetto diverso e ammetterò che sarebbe ragionevole se non lo facesse. Ma allora che non rompa le scatole a me con le sue delicatezze!
Dopo quei colpi mi risvegliai – e qui cominciano pian piano i miei ricordi personali – in una gabbia, sul ponte mediano del vaporetto Hagenbeck. Non era una gabbia a quattro pareti; piuttosto si trattava di solo tre pareti saldamente appoggiate a un baule; il baule formava così la quarta parete. Il tutto era troppo basso per stare in piedi e troppo stretto per stare seduti. Perciò mi accoccolai sulle ginocchia piegate e un po’ tremanti e, poiché probabilmente in un primo tempo non volevo vedere nessuno ma preferire rimanermene al buio, mi voltai verso il baule, mentre dietro di me le sbarre della gabbia mi entravano nella carne. Custodire nei primi tempi in questo modo gli animali selvatici è considerato vantaggioso, e dopo la mia esperienza non posso negare che, in un senso umano, è proprio così.
Ma allora non ci pensavo. Per la prima volta nella mia vita non avevo vie d’uscita; per lo meno non ne avevo davanti a me; davanti a me c’era il baule, un’asse stretta contro l’altra. Fra le assi c’era sì un’apertura che le attraversava, e quando la scoprii la prima volta la salutai con l’urlo felice di chi non comprende, ma questa apertura era di gran lunga insufficiente anche per infilarci la coda, e tutta la forza di una scimmia non era sufficiente ad allargarla.
Come poi mi hanno detto, ero insolitamente poco rumoroso, e da questo se ne concluse che o sarei crepato presto oppure, se superavo il primo periodo critico, sarei stato molto adatto a essere addomesticato. Superai questo periodo. Un sordo singhiozzo, un doloroso spulciarsi, lo stanco leccare una noce di cocco, battere con la testa la parete del baule, mostrare la lingua all’avvicinarsi di qualcuno – ecco le prime occupazioni della mia nuova vita. Ma in tutto ciò un solo sentimento: nessuna via d’uscita. Naturalmente ciò che allora sentivo come scimmia posso descriverlo oggi solo con parole umane e perciò manco il bersaglio, ma anche se non posso più raggiungere l’antica verità di scimmia questa è per lo meno sulla linea della mia descrizione, su questo non ho dubbi.
Fino ad allora avevo avuto tante via d’uscita, e ora neppure una. Ero saldamente in trappola. Se mi avessero inchiodato, la mia libertà di movimento non sarebbe stata minore. E questo perché? Puoi anche grattarti la pelle fra le dita dei piedi, ma non troverai il perché. Non avevo vie d’uscita, dovevo però procurarmele, altrimenti non avrei potuto vivere. Sempre attaccato a questa parete di baule – sarei senza dubbio crepato. Ma da Hagenbeck le scimmie devono stare contro la parete del baule – e così smisi di essere una scimmia. Una linea di pensiero chiara e bella, che devo avere in qualche modo covato in pancia, dato che le scimmie pensano con la pancia.
Temo di non essere capito quando parlo di via d’uscita. Uso questo termine nel suo senso più completo e abituale. E’ con intenzione che non dico libertà. Non alludo a questo grande sentimento della libertà in tutte le direzioni. Come scimmia forse la conoscevo, e ho incontrato uomini che ambiscono ad essa. Ma per quanto mi riguarda, non desideravo la libertà allora come non la desidero oggi. Fra parentesi: parlando di libertà gli uomini si ingannano un po’ troppo spesso. E come la libertà va annoverata fra i sentimenti più sublimi, così anche il corrispondente inganno è dei più sublimi. Spesso nei varietà, prima del mio numero, ho visto qualche coppia di artisti darsi da fare lassù sotto il tendone sul trapezio. Si lanciavano, si altalenavano, saltavano, si libravano abbracciati, uno teneva l’altro per i capelli con i denti. “Anche questa è libertà umana”, pensavo, “un movimento padrone di sé.” O derisione della sacra natura! Non c’è costruzione che resterebbe in piedi per le risate delle scimmie di fronte a un tale spettacolo.
No, non era la libertà che volevo. Solo una via d’uscita; a destra, a sinistra, era lo stesso; non avevo altre pretese; la via d’uscita poteva anche essere un inganno; la pretesa era piccola, l’inganno non poteva essere più grande. Avanti, avanti! Pur di non restare fermo a braccia sollevate, schiacciato contro la parete di un baule.
Oggi vedo con chiarezza; senza la più grande tranquillità interiore non avrei mai potuto venirne fuori. E in effetti forse devo tutto ciò che sono diventato alla tranquillità che mi invase, là nella nave, dopo i primi giorni. Ma la tranquillità a sua volta la devo all’equipaggio della nave.
Sono brave persone, nonostante tutto. Ancora oggi ricordo volentieri il suono dei loro passi pesanti, che risuonavano allora nel mio dormiveglia. Avevano l’abitudine di prendere tutto con estrema lentezza. Se qualcuno voleva stropicciarsi gli occhi, alzava la mano come sollevando un peso. I loro scherzi erano grossolani, ma cordiali. Le loro risate erano sempre miste a una tosse che suonava pericolosa, e invece era insignificante. Avevano sempre in bocca qualcosa da sputare, e dove sputassero era per loro indifferente. Si lamentavano sempre di trovarsi addosso le mie pulci; ma non ce l’avevano mai seriamente con me; sapevano bene che nella mia pelliccia le pulci prosperavano e anche che le pulci sono buone saltatrici; e perciò si mettevano l’animo in pace. Quando non erano in servizio, a volte alcuni di loro si sedevano in semicerchio intorno a me; parlavano appena, ma si limitavano a tubare l’uno in direzione dell’altro; fumavano, sdraiati sul baule, la pipa; si davano botte sulle ginocchia appena facevo il più piccolo movimento; e ogni tanto uno prendeva un bastone e mi grattava là dove preferivo. Se oggi mi invitassero a fare un viaggio su una tale nave certo declinerei l’invito, ma è altrettanto certo che quando penso a quel ponte mediano non ho soltanto brutti ricordi.
La tranquillità che mi ero guadagnata fra questa gente mi trattenne innanzitutto da ogni tentativo di fuga. Ripensandoci oggi mi sembra che avevo almeno il presentimento che avrei dovuto prima o poi trovare una via d’uscita, se volevo vivere, ma che tale via d’uscita non si raggiungeva con la fuga. Non so più se una fuga era possibile, anche se credo di sì; a una scimmia la fuga dovrebbe sempre essere possibile. Con i miei denti di oggi devo stare attento anche quando rompo una semplice noce, ma allora con il tempo mi sarebbe certo riuscito di rompere a morsi la chiusura della gabbia. Non lo feci. Che cosa ci avrei guadagnato? Appena messa fuori la testa mi avrebbero subito ripreso e rinchiuso in una gabbia ancor peggiore; oppure senza rendermene conto sarei fuggito fra altri animali, magari in mezzo ai boa, e sarei soffocato nel loro abbraccio; o magari mi sarebbe riuscito di raggiungere il ponte e saltare fuori, così mi sarei dondolato per un poco sull’oceano e poi sarei affogato. Gesti disperati. Non calcolavo come un uomo, ma sotto l’influsso di chi mi circondava mi comportavo come se avessi calcolato.
Non calcolavo, ma osservavo in tutta tranquillità. Guardavo questi uomini andare su e giù, sempre le stesse facce, gli stessi movimenti, a volte mi sembrava che fosse sempre lo stesso uomo. Quest’uomo o questi uomini camminavano dunque indisturbati. Intravidi, come per ispirazione, un superiore obiettivo. Nessuno mi prometteva che la gabbia sarebbe stata aperta se fossi diventato come loro. Non si fanno simili promesse per imprese apparentemente irrealizzabili. Ma se le imprese vengono portate a termine, allora in seguito anche le promesse compaiono proprio là dove prima le si era cercate invano. Ora, in questi uomini di per sé non c’era nulla che mi attirasse molto. Se fossi un adepto di quella libertà di cui parlavo prima, avrei certo preferito l’oceano alla via d’uscita che mi si mostrava nel torbido sguardo di costoro. In ogni caso però io li osservavo già da molto tempo prima di pensare a queste cose, furono anzi solo le osservazioni accumulate a spingermi in quella definita direzione.
Era così facile imitare la gente. A sputare, imparai fin dai primi giorni. Ci sputavamo in faccia a vicenda; l’unica differenza era che dopo io mi leccavo la faccia per pulirla, loro no. Presto fumavo la pipa come un vecchio; se premevo il suo fornello con il pollice, tutto il ponte ne rideva; solo la differenza fra una pipa vuota e una carica mi rimase a lungo oscura.
La fatica maggiore me la procurò la bottiglia di grappa. L’odore mi ripugnava; mi costrinsi con tutte le forze; ma ci vollero settimane perché riuscissi a vincermi. Queste lotte interiori, sorprendentemente, furono dall’equipaggio prese sul serio più di ogni altra cosa. Ora non riesco più, nemmeno nel ricordo, a distinguere le persone, ma uno di loro tornava sempre, solo o in compagnia, di giorno o di notte, alle ore più diverse; mi si metteva davanti con la bottiglia e mi dava lezioni. Non mi capiva, voleva sciogliere l’enigma del mio essere. Stappava la bottiglia lentamente e mi guardava, come per vedere se avevo capito; confesso che lo osservavo sempre con un’attenzione selvatica e precipitosa; nessun insegnante umano troverebbe in tutto il mondo un allievo umano altrettanto diligente; stappata la bottiglia, la portava alla bocca; io lo seguivo con lo sguardo fino alla gola; contento di me, mi fa un cenno e porta la bottiglia alle labbra; io, affascinato dalla progressiva conoscenza, stridendo mi gratto per lungo e per largo dove capita; lui se ne rallegra, alza la bottiglia e beve un sorso; io, impaziente e disperato per la voglia di imitarlo, mi imbratto nella mia gabbia, cosa che di nuovo lo riempie di soddisfazione; ora allontana ampiamente da sé la bottiglia e di slancio la riavvicina, e, piegato esageratamente indietro per insegnarmi, la vuota in un sorso. Io, stanco per l’eccessivo desiderio, non posso più seguirlo e pendo debolmente dalle sbarre, mentre lui conclude la sua lezione di teoria grattandosi la pancia con un ghigno.
Solo ora comincia l’esercizio pratico. Non sono già esaurito dalla teoria? Sì, del tutto esaurito. Ciò fa parte del mio destino. Ciononostante, afferro meglio che posso la bottiglia che mi viene tesa; tremando la stappo; con questo successo ecco che pian piano acquisisco nuove forze; alzo la bottiglia, e in questo gesto sono ormai quasi indistinguibile dal mio modello; la porto alla bocca e – e la scaglio lontano con orrore, con orrore, benché sia vuota e piena solo dell’odore, la scaglio con orrore per terra. Questo è uno sconforto per il mio insegnante, e ancor maggiore per me; e non posso riconciliare né lui né me per il fatto che, gettata via la bottiglia, non dimentico di grattarmi la pancia e ghignare.
Fin troppe volte la lezione andava così. E, sia detto a onore del mio insegnante: non era cattivo con me; certo, ogni tanto mi appoggiava la pipa accesa sulla pelliccia, finché questa, dove arrivavo con difficoltà, cominciava a bruciare, ma allora lui stesso me la spegneva con la sua gigantesca mano piena di bontà; non era cattivo con me, capiva che entrambi lottavamo dalla stessa parte contro la natura di scimmia, e che a me toccava il compito più difficile.
Che vittoria fu allora per lui come per me, quando una sera, davanti a un grande pubblico – forse era una festa, un grammofono suonava, un ufficiale passeggiava fra la gente – quando in quella sera, a tutti inosservato, afferrai una bottiglia di grappa dimenticata per caso davanti alla mia gabbia, la stappai secondo i dettami della scuola sotto l’attenzione crescente degli astanti, la portai alla bocca e senza esitare, senza storcer la bocca, come un esperto bevitore, con gli occhi sbarrati, la gola traboccante, la vuotai letteralmente fino all’ultimo goccio; scagliai lontano la bottiglia non più con disperazione, ma da vero artista; certo, dimenticai di grattarmi la pancia; in compenso però, forse perché non potevo più trattenermi o perché i miei sensi erano preda dell’ebbrezza, esclamai un “Ehilà!” con timbro umano, con questo grido saltai nella comunità degli umani e percepii la loro eco: “Sentite, sta parlando!” come un bacio su tutto il mio corpo gocciolante di sudore.
Ripeto: non mi attirava imitare gli uomini; li imitavo solo perché cercavo una via d’uscita, nient’altro. Inoltre, con quella vittoria ancora avevo ottenuto poco. La voce mi sparì di nuovo subito dopo; solo dopo mesi riuscii a ritrovarla; la ripugnanza contro la bottiglia di grappa si ripresentò moltiplicata. Ma la strada era tracciata davanti a me una volta per sempre.
Quando fui consegnata ad Amburgo al primo domatore, compresi subito l’alternativa che mi si poneva: zoo o varietà. Non ebbi esitazioni. Mi dissi: cerca con tutte le tue forze di arrivare al varietà; questa è la via d’uscita; lo zoo è soltanto una nuova gabbia; se ci entri sei perduto.
E così, signori, ho imparato. Ah, si impara bene quando si è obbligati; si impara, quando si vuol trovare una via d’uscita; si impara senza riguardi per nessuno. Ci si sorveglia da soli con la frusta; e alla minima resistenza ci si strazia le carni. Come sparata fuori, la natura di scimmia uscì da me e sparì, tanto che il mio primo istruttore finì per diventare lui stesso simile a una scimmia, e presto dovette abbandonare la mia istruzione e ricoverarsi in clinica. Fortunatamente presto ne uscì.
Ma io dovevo logorare molti istruttori, spesso diversi istruttori allo stesso tempo. Quando fui più sicuro delle mie capacità, quando il pubblico cominciò a seguire i miei progressi e il futuro a farsi più luminoso, io stesso mi prendevo degli istruttori, li mettevo in cinque stanze consecutive e imparavo da tutti contemporaneamente saltando senza posa da una stanza all’altra.
Quali progressi! Come penetravano i raggi della scienza da ogni parte nel cervello che si risvegliava! Non lo nego: ciò mi rendeva felice. Ma confesso anche che allora come ora non sopravvalutavo tutto ciò. Con uno sforzo quale finora non si è ripresentato sulla terra, ho raggiunto il grado di istruzione medio di un europeo. Questo in sé sarebbe un nulla, ma è pur sempre qualcosa dato che mi ha liberato dalla gabbia e mi ha offerto questa particolare via d’uscita, questa via d’uscita umana. Nella vostra lingua esiste la bellissima espressione: “imboscarsi”; è proprio quello che ho fatto io, mi sono imboscato. Non c’erano altre vie, se si premette che non si poteva scegliere la libertà.
Se ora riconsidero la mia evoluzione e ciò che ho ottenuto finora, non posso lamentarmi né dichiararmi soddisfatto. Con le mani nei pantaloni, la bottiglia di vino sul tavolo, un po’ sto sdraiato, un po’ mi metto nella sedia a dondolo e guardo dalla finestra. Se viene una visita la ricevo come si conviene. Il mio impresario sta nell’anticamera; se suono, viene e ascolta cosa ho da dire. La sera c’è quasi sempre lo spettacolo, e ormai non potrei avere più successo di così. Se torno tardi dai banchetti, dalle società scientifiche o da una piacevole compagnia, mi aspetta a casa una piccola scimpanzé semiaddomesticata, e presso di lei me la spasso alla maniera delle scimmie. Di giorno però non la voglio vedere; ha negli occhi la follia dell’animale addestrato e confuso; solo io lo vedo e non riesco a sopportarlo.
Nel complesso, ad ogni modo, ho raggiunto quel che volevo raggiungere. Non si dica che non ne valeva la pena. Del resto non mi interessano i giudizi umani, io voglio solo diffondere la conoscenza, fare relazioni, e anche questa che ho presentato davanti a voi, eccellenti signori dell’Accademia, era soltanto una relazione.
* * *
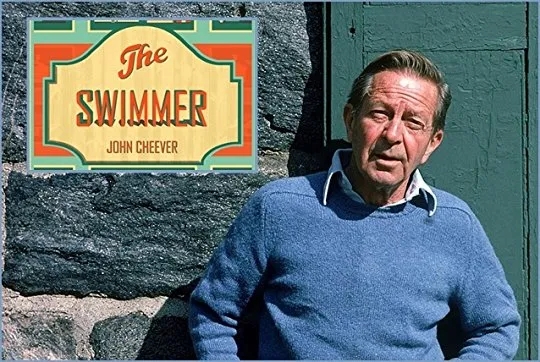
John Cheever
IL NUOTATORE
Era una di quelle domeniche di mezza estate in cui tutti se ne stanno seduti e continuano a ripetere: “Ho bevuto troppo ieri sera.”
Si poteva udire i parrocchiani che lo bisbigliavano all’uscita della chiesa, si poteva udirlo anche dalle labbra del parroco, mentre si infilava faticosamente la tonaca nel vestibolo, si poteva udirlo nei campi di golf e di tennis, e anche nella riserva per la protezione della fauna, dove il presidente della locale associazione ornitologica era in preda a una feroce emicrania. “Ho bevuto troppo,” gemeva Donald Westerhazy. “Tutti abbiamo bevuto troppo,” gli faceva eco Lucinda Merrill.
“Dev’essere stato il vino,” osservava Helen Westerhazy. “Ne ho bevuto troppo di quel vino rosso.” Ciò avveniva ai bordi della piscina di casa Westerhazy. La piscina, alimentata da un pozzo artesiano con un’alta percentuale di ferro, aveva l’acqua d’un pallido colore verdastro. Era una bella giornata. A occidente si vedeva una massiccia formazione di nuvole cumuliformi, ed era così simile a una città vista in lontananza dalla prua di una nave che s’avvicina, che si sarebbe potuto darle un nome, Lisbona o Hackensack. Il sole era caldo. Neddy Merrill era disteso vicino all’acqua verdognola, una mano immersa nell’acqua e l’altra stretta intorno a un bicchiere di gin. Era un uomo snello, con quella particolare snellezza della gioventù, e pur essendo tutt’altro che giovane, quel mattino era scivolato giù dalla ringhiera di casa sua, dando poi una pacca sul sedere della statua in bronzo di
Afrodite sul tavolino nell’atrio mentre trotterellava verso l’odore del caffè in sala da pranzo. Merrill poteva essere paragonato a una giornata d’estate, in particolare alle sue ultime ore, e anche se non aveva una racchetta da tennis né una borsa da vela, evocava un’immagine di gioventù sportiva e di
tempo clemente. Aveva appena finito di nuotare e ora respirava profondamente, come se volesse mandar giù nei polmoni tutte le componenti di quel momento, il calore del sole e l’intensità del suo piacere; sembrava che tutte venissero aspirate dentro il suo petto. Abitava a Bullet Park, una quindicina di chilometri a sud, dove le sue quattro splendide figlie dovevano aver terminato di pranzare e stavano forse giocando a tennis. In quel momento gli venne l’idea che, seguendo un percorso ad angolo in direzione sud ovest, sarebbe potuto arrivare a casa sua a nuoto.
La sua vita non era condizionata, e il piacere che gli dava questa constatazione non poteva essere spiegato con un complesso di fuga.
Gli sembrava di vedere, con un occhio da cartografo, quella catena di piscine, quel corso d’acqua quasi sotterraneo che si snodava attraverso la contea. Aveva fatto una scoperta, aveva dato un contributo alla geografia moderna, e quel corso d’acqua l’avrebbe chiamato Lucinda, col nome di sua moglie. Non era uno che amava particolarmente gli scherzi, né era un buffone, ma era volutamente originale, e si considerava in generale, e modestamente, un personaggio leggendario.
Era una bella giornata, e gli sembrava che una lunga nuotata ne avrebbe esaltato la bellezza. Si tolse il golf che teneva sulle spalle e si tuffò in acqua.
Nutriva un inesplicabile disprezzo per quegli uomini che non si tuffavano in acqua. Nuotava una specie di crawl irregolare, respirando a ogni bracciata oppure ogni quattro bracciate, e contando mentalmente l’uno-due uno-due del battito dei piedi. Non era uno stile adatto alle lunghe distanze, ma la pratica domestica del nuoto aveva imposto a questo sport alcune consuetudini, e in quella parte del mondo era convenzionale quel tipo di crawl. Il sentirsi avvolto e sostenuto da quell’acqua verdognola gli sembrava non tanto un piacere quanto un ritorno a una condizione naturale, e gli sarebbe piaciuto nuotare senza calzoncini da bagno, ma questo non era possibile, in considerazione del suo progetto. Si issò sul bordo opposto della piscina, lui che non usava mai la scaletta, e s’incamminò attraverso il prato. Quando Lucinda gli domandò dove stava andando, le rispose che ritornava a casa a nuoto.
Le uniche mappe e cartine a cui fare riferimento erano nella memoria o nell’immaginazione, ma erano abbastanza chiare. Per primi venivano i Graham, gli Hammer, i Lear, gli Howland e i Crosscup. Poi avrebbe attraversato Ditmar Street fino alla casa dei Bunker, e da lì, dopo un breve trasbordo, sarebbe arrivato alle piscine dei Levy e dei Welcher, e alla piscina pubblica dei Lancaster. Seguivano poi le piscine degli Halloran, dei Sachs, dei Biswanger, e quelle di Shirley Adams, dei Gilmertin e dei Clyde. Era una stupenda giornata, e il fatto di vivere in un mondo così generosamente fornito di acqua gli sembrava un dono del cielo, una benedizione. Si sentiva il cuore leggero, e cominciò a correre sull’erba. L’impresa di avventurarsi verso casa seguendo questa insolita rotta gli dava la sensazione di essere un pellegrino, un esploratore, un uomo del destino, e sapeva che sul percorso avrebbe incontrato molti amici, tutti amici assiepati lungo le rive del fiume Lucinda.
Scavalcò una siepe che divideva il terreno dei Westerhazy da quello dei Graham, camminò sotto alcuni alberi di melo, oltrepassò il capanno della pompa e del filtro dell’acqua, e arrivò così alla piscina dei Graham. “Ehilà, Neddy!,” esclamò la signora Graham. “Che magnifica sorpresa! tutta la mattina che ti cerco al telefono. Su, vieni a bere qualcosa.” Al pari di un vero esploratore, si rendeva conto che doveva diplomaticamente rispettare i costumi e le tradizioni di ospitalità degli indigeni locali, se voleva raggiungere la sua destinazione. Non voleva sconcertare i Graham, né sembrar loro sgarbato, ma nemmeno aveva il tempo per trattenersi a lungo a casa loro. Attraversò a nuoto la loro piscina in tutta la sua lunghezza, poi li raggiunse sotto il sole, e pochi minuti dopo fu salvato dall’arrivo di due auto cariche di loro amici del Connecticut.
Durante i chiassosi saluti che seguirono, riuscì così a squagliarsela inosservato. Scese il prato davanti alla casa dei Graham, scavalcò una siepe spinosa e attraverso un terreno incolto arrivò alla casa degli Hammer. Alzando lo sguardo dal suo roseto, la signora Hammer lo vide nuotare nella sua piscina, anche se non era sicura che fosse proprio lui. I Lear lo udirono tuffarsi in acqua attraverso le finestre aperte del soggiorno. Gli Howland e i Crosscup non erano in casa. Uscito dalla piscina degli Howland, Neddy attraversò Ditmar Street e si diresse verso la casa dei Bunker, da dove gli giungevano, pur da lontano, gli echi rumorosi di una festa.
L’acqua rifrangeva il rumore delle voci e delle risate, e sembrava tenerle sospese a mezz’aria. La piscina dei Bunker era su un rialzo di terreno, e Neddy salì alcuni gradini che portavano a una terrazza, dove una trentina di persone stavano bevendo. L’unica persona in acqua era Rusty Towers, che galleggiava su un materassino di gomma.
Oh, com’erano incantevoli e lussureggianti le rive del fiume Lucinda! Uomini e donne prosperi erano riuniti intorno alle sue acque color zaffiro, mentre i camerieri in giacca bianca servivano loro bicchieri di gin gelato. Sopra alla testa vedeva volteggiare nel cielo un aereo rosso da addestramento che sembrava gioioso come un bambino sull’altalena. Ned provò un momentaneo sentimento d’affetto per quella scena, un senso di tenerezza per quella gente lì riunita, un sentimento che gli sembrava di poter toccare con mano. In lontananza, udiva il brontolio del tuono. Non appena lo vide, Enid Bunker cominciò a strillare: “Oh, guardate chi c’è! Che magnifica sorpresa! Quando Lucinda mi ha detto che non potevate venire, mi sono sentita quasi morire.” Si fece strada attraverso la folla verso di lui, e quando ebbe finito di baciarlo lo condusse verso il bar, una marcia che fu rallentata dal fatto che Ned dovette fermarsi a baciare altre nove o dieci donne e a stringere la mano di altrettanti uomini. Un barista sorridente, che Ned aveva già visto a un centinaio di feste, gli servì un gin tonic, poi si trattenne per un attimo al bar, cercando di non farsi coinvolgere in nessuna conversazione che potesse attardare il suo viaggio. Quando gli sembrò di essere quasi circondato dagli invitati, Ned si tuffò nella piscina e nuotò lungo il bordo per evitare di entrare in collisione con il materassino di Rusty. Giunto all’altra estremità della piscina, passò accanto ai Tomlinson con uno sfolgorante sorriso e si avviò trotterellando lungo il sentiero del giardino. La ghiaia gli faceva male ai piedi, ma questo era l’unico inconveniente. Gli invitati erano tutti raccolti intorno alla piscina, e avviandosi verso la casa, Ned udiva affievolirsi il rumore vivace delle voci riflesse dall’acqua, mentre si faceva più forte quello di una radio nella cucina dei Bunker, dove qualcuno stava ascoltando la cronaca di una partita di pallone. Già, era domenica pomeriggio. Si fece strada attraverso le auto parcheggiate e percorse il bordo erboso del vialetto d’accesso fino in Alewives Lane. Gli seccava farsi vedere per strada in calzoncini da bagno, ma non c’era traffico a quell’ora, e percorse il breve tragitto fino all’ingresso della casa dei Levy, segnato col cartello PROPRIETA’ PRIVATA e con la cassetta verde del New York Times. Tutte le porte e le finestre della grande casa erano aperte, ma non c’erano segni di vita, nemmeno un cane che abbaiasse. Girando intorno alla casa arrivò alla piscina, e lì vide che i Levy se n’erano andati da poco. Bicchieri, bottiglie e piatti di noccioline erano posati su un tavolo all’estremità della piscina, dove c’era un gazebo o spogliatoio in cui erano appesi lampioncini giapponesi. Dopo aver percorso a nuoto la vasca, prese un bicchiere e si versò da bere. Era il quarto o il quinto bicchiere che beveva, e aveva già percorso a nuoto quasi la metà del fiume Lucinda. Si sentiva stanco, pulito, e contento di esser solo in quel momento, contento di tutto quanto. Stava per arrivare un temporale. La formazione di nuvole cumuliformi si era alzata ed era divenuta più scura, e mentre era lì seduto udì di nuovo il rombo sordo del tuono. L’aereo da addestramento volteggiava ancora sopra la sua testa, e a Ned sembrava quasi di poter udire il pilota che rideva di piacere nella luce del pomeriggio, ma quando si udì un altro boato di tuoni, il pilota virò per far ritorno alla base. Si udì poi il fischio di una locomotiva, e Ned si domandò che ore erano. Le quattro? O le cinque? Pensò alla stazione a quell’ora, dove un cameriere con lo smoking coperto dall’impermeabile, una nana con un mazzo di fiori avvolti in carta di giornale, una donna con gli occhi rossi di pianto erano in attesa del treno locale. Improvvisamente si fece buio, era quello il momento in cui gli uccellini sembrano intonare tutti insieme un canto che è un acuto e riconoscibile annuncio del temporale che s’avvicina. Poi udì il piacevole rumore dell’acqua che scrosciava dalle fronde di una quercia dietro di lui, come se fosse stato aperto un rubinetto. Quel rumore d’acqua scrosciante gli arrivò poi dalle fronde di tutti gli alberi lì intorno. Ma perché amava tanto i temporali, perché lo eccitava il rumore delle porte spalancate dal vento e delle folate di pioggia che spazzavano violentemente le scale di casa, perché il semplice compito di chiudere le imposte di una vecchia casa gli sembrava così necessario e urgente, perché le prime note cristalline di un vento di tempesta avevano per lui il suono inconfondibile delle buone notizie, dell’allegria, della lieta novella? Poi si sentì un forte boato seguito dall’odore della cordite, e la pioggia investì i lampioncini giapponesi che la signora Levy aveva acquistato a Kyoto due anni prima, o era stato forse l’anno
scorso? Rimase nello spogliatoio dei Levy finché non fu passato il temporale. La pioggia aveva raffreddato l’aria, e Ned si sentì percorrere da un brivido. La forza del vento aveva spogliato un acero di foglie rosse e gialle, che giacevano ora sparse sull’erba e nell’acqua. Essendo mezza estate, l’albero doveva essere malato, ma quel primo segnale dell’autunno gli diede una peculiare malinconia.
Poi si riprese dal suo torpore, vuotò il bicchiere e si avviò verso la piscina dei Welcher. Per arrivarvi dovette attraversare la pista d’equitazione dei Lindley, e fu sorpreso di trovarla infestata da erbacce e senza gli ostacoli, che erano stati smontati. Si domandò se i Lindley avevano venduto i loro cavalli o se invece, dovendo partire per le vacanze estive, li avevano affidati a qualche scuderia. Gli sembrava di aver sentito dire qualcosa, a proposito dei Lindley e dei loro cavalli, ma non ricordava bene. Proseguì a piedi nudi sull’erba bagnata, fino alla casa dei Welcher, dove trovò che la loro piscina era stata prosciugata.
Questa interruzione nel flusso del suo corso d’acqua gli diede un assurdo senso di delusione, e si sentì come un esploratore che si spinge alla ricerca delle sorgenti di un fiume e si trova invece davanti a un ramo morto. Era deluso e sconcertato. Era un fatto abbastanza normale che la gente se ne andasse via in estate, ma nessuno aveva mai prosciugato la piscina. I Welcher dovevano essere andati via definitivamente. I mobili del giardino erano stati piegati, ammucchiati e coperti con tela cerata. Anche la cabina era chiusa a chiave, così come tutte le finestre della casa, e quando arrivò al vialetto d’accesso davanti alla casa vide un cartello con la scritta IN VENDITA inchiodato a un albero. Quando aveva sentito l’ultima volta i Welcher, quand’era stato, cioè, che lui e Lucinda avevano ricevuto uno sgradito invito a cena in casa loro? Sembrava soltanto una settimana o due prima. Era la sua memoria che vacillava, o era il fatto che avendola esercitata a rimuovere i ricordi sgradevoli, il suo senso della realtà era ora offuscato? Poi udì in lontananza il rumore di una partita di tennis. Quel rumore lo rallegrò, spazzò via le sue apprensioni e gli consentì di considerare con indifferenza il cielo coperto e l’aria più fredda. Quello era il giorno in cui Neddy Merrill aveva attraversato a nuoto tutta la contea, che giornata! E così si avviò a compiere il suo trasbordo più difficile.
Se quel pomeriggio qualcuno avesse fatto una gita domenicale, avrebbe potuto vederlo, seminudo, ai margini della strada statale 424, in attesa che si presentasse l’occasione di attraversarla. E si sarebbe domandato allora se quell’uomo era vittima di qualche scherzo di cattivo gusto, se la sua auto si era rotta, o se era semplicemente un pazzo. Lì, a piedi scalzi tra le immondizie dell’autostrada, tra lattine di birra, stracci e pezzi di pneumatici scoppiati, esposto a ogni sorta diridicolo, Ned era una figura patetica. Già al momento della partenza sapeva che quel tratto di strada, segnato sulla sua cartina, faceva parte del percorso, ma una volta giunto davanti a quelle file di auto che si snodavano nella luce d’estate, si era trovato impreparato. Si era visto deriso, beffeggiato,bersagliato perfino da una lattina di birra, e non aveva né la dignità, né il senso dell’umorismo sufficienti per far fronte alla situazione.
Sarebbe potuto tornare indietro, a casa dei Westerhazy, dove Lucinda doveva essere ancora distesa al sole. Non aveva firmato niente, non aveva giurato niente, non aveva sottoscritto impegni con nessuno, nemmeno con se stesso. E perché, allora, pur convinto com’era che tutto l’orgoglio umano doveva essere subordinato al buonsenso, non era capace di voltarsi e di tornare indietro? Perché era così deciso a portare a termine il suo viaggio, anche se ciò poteva mettere a repentaglio la sua stessa vita? Quand’era successo che quel gioco, quello scherzo, quell’esibizione erano divenuti una cosa seria? Non poteva tornare indietro, e non riusciva nemmeno a ricordare chiaramente l’acqua verde della piscina dei Westerhazy, la sensazione che aveva provato di respirare le componenti di quella giornata, le voci rilassate degli amici che dicevano di aver bevuto troppo. Nello spazio di un’ora, più o meno, aveva percorso una distanza che rendeva impossibile il suo ritorno. Un vecchio che arrancava sull’autostrada a venti all’ora lo lasciò passare e poté arrivare così allo spartitraffico erboso in mezzo alla strada. Lì si trovò esposto al ridicolo degli automobilisti diretti verso nord, ma dopo una quindicina di minuti riuscì ad attraversare anche quella carreggiata. Da lì il tragitto era breve fino al centro di ricreazione alla periferia del villaggio di Lancaster, dove c’erano alcuni campi per la pallamano e una piscina pubblica.
L’effetto delle voci sull’acqua, l’illusoria impressione di allegria e di attesa, erano gli stessi che aveva avvertito in casa dei Bunker, ma qui i suoni delle voci erano più forti, aspri e acuti, e non appena entrò nel recinto affollato della piscina si trovò davanti ai suoi regolamenti da caserma:
“TUTTI I BAGNANTI DEVONO FARE LA DOCCIA PRIMA DI ENTRARE IN ACQUA. TUTTI I BAGNANTI DEVONO LAVARSI I PIEDI. TUTTI I BAGNANTI DEVONO PORTARE APPESA LA MEDAGLIETTA DI RICONOSCIMENTO.”
Fece la doccia, si lavò i piedi con una soluzione lattiginosa dall’odore amarognolo, poi si fece strada verso il bordo della vasca, che puzzava di cloro e gli sembrava una fogna. Due bagnini in cima a una torretta soffiavano nei loro fischietti da poliziotti a intervalli che sembravano regolari e insultavano i bagnanti attraverso gli altoparlanti. Neddy pensò con nostalgia all’acqua color zaffiro della piscina dei Bunker e si disse che in quest’acqua poteva anche contaminarsi, compromettere il suo aspetto florido e seducente, ma poi si ricordò di essere un esploratore, un pellegrino, e pensò che quella era soltanto un’ansa stagnante del grande fiume Lucinda. Allora si tuffò, storcendo il naso con disgusto, in quell’acqua che puzzava di cloro, nuotando con la testa fuori per evitare collisioni, ma nonostante ciò fu continuamente urtato, investito e spruzzato dagli altri bagnanti. Quando arrivò dove l’acqua era più bassa, udì che i due bagnini stavano gridando al suo indirizzo: “Ehi tu, tu che non hai la medaglietta, esci subito dall’acqua!” Ned uscì, ma i bagnini non avevano la possibilità di inseguirlo, e allora se ne andò, in mezzo a quella puzza di olio abbronzante e di cloro, scavalcò una palizzata e uscì passando attraverso i campi di pallamano. Attraversata la strada, entrò nel bosco della proprietà degli Halloran. Il bosco non era stato pulito, ed era difficile e insidioso camminare lì a piedi nudi, ma alla fine arrivò al prato e alla siepe ben potata che circondava la piscina.
Gli Halloran erano due anziani coniugi immensamente ricchi, che sembravano compiacersi al sospetto che li circondava di essere comunisti. Erano ardenti riformatori, questo sì, ma non comunisti, tuttavia quando erano accusati di essere sovversivi, come talvolta succedeva, ne sembravano compiaciuti ed elettrizzati. La siepe di faggi era ingiallita, e Ned pensò che anch’essi fossero malati come l’acero di Levy. Chiamò gli Halloran ad alta voce, per avvertirli del suo arrivo e per farsi perdonare in qualche modo quell’intrusione nella loro intimità. Per qualche motivo che non gli avevano mai spiegato, gli Halloran non indossavano costumi da bagno, un vezzo che era davvero inspiegabile, anche se il loro nudismo era forse un aspetto del loro irriducibile ardore riformatore. Ned si spogliò educatamente dei suoi calzoncini da bagno prima di varcare un passaggio della siepe. La signora Halloran, una donna robusta con i capelli bianchi e un volto sereno, stava leggendo il Times, mentre suo marito era intento a togliere dall’acqua le foglie di faggio con un grande retino. Non sembrarono né sorpresi né dispiaciuti di vederlo arrivare. La loro piscina, forse la più vecchia della zona, era un rettangolo di pietra alimentato da un ruscello. Non aveva filtro né pompa, e la sua acqua aveva l’opaco colore dorato del corso d’acqua. “Sto attraversando a nuoto la contea, “annunciò Ned. “Non sapevo che fosse possibile,” osservò la signora Halloran.
“Be’, io ce l’ho fatta fin dalla casa dei Westerhazy,” dichiarò Ned. “Devono essere cinque o sei chilometri.”
Lasciò i suoi calzoncini sul bordo dell’acqua più alta, andò a piedi dov’era più bassa, poi fece a nuoto la vasca. Mentre si stava issando fuori dall’acqua, udì la signora Halloran che diceva: “Ci è dispiaciuto immensamente sapere di tutte le tue disgrazie, Neddy.”
“Le mie disgrazie?”, domandò Ned. “Non capisco di che cosa parli.”
“Be’ abbiamo saputo che hai venduto la casa e che le tue povere bambine…”
“Non ricordo proprio di aver venduto la casa,” replicò Ned. “E in quanto alle ragazze, sono a casa.” “Già,” sospirò la signora Halloran. “Già…” La sua voce riempiva l’aria di una malinconia fuori stagione, e Ned le disse allora in tono brusco: “Be’, grazie della nuotata.”
“Buon viaggio!”, lo salutò la signora Halloran.
Oltrepassata la siepe, si infilò i calzoncini e li legò, ma gli erano larghi, e si domandò allora se, nell’arco di un solo pomeriggio, potesse aver perso peso. Aveva freddo e si sentiva stanco, e oltre a ciò la nudità degli Halloran e l’acqua opaca della loro piscina lo avevano depresso. Era una nuotata troppo lunga per le sue forze, ma come avrebbe potuto prevederlo quel mattino, mentre scivolava giù
per la ringhiera e quando stava disteso al sole in casa dei Westerhazy? Sentiva le braccia fiacche, le gambe molli, le giunture che dolevano. Peggio ancora era il freddo che sentiva nelle ossa, insieme con la sensazione che non sarebbe mai più riuscito a riscaldarsi. Le foglie cadevano intorno a lui, e a un tratto sentì nel vento l’odore di legna bruciata. Chi poteva bruciare legna in quella stagione dell’anno?
Sentiva il bisogno di bere qualcosa. Un bicchiere di whiskey l’avrebbe riscaldato, l’avrebbe tirato su di morale, gli avrebbe dato le forze per compiere l’ultimo tratto del suo viaggio, avrebbe rinvigorito la sua idea che quella di attraversare a nuoto tutta la contea era un’impresa valorosa e originale. Anche quelli che attraversavano a nuoto la Manica bevevano bicchierini di brandy.
Aveva proprio bisogno di uno stimolante. Attraversò il prato davanti alla casa degli Halloran e percorse poi il vialetto che portava alla casa che essi avevano fatto costruire per la loro unica figlia, Helen, e suo marito Eric Sachs. I Sachs avevano una piscina piccola, e Ned li trovò lì accanto.
“Oh, Neddy!” esclamò Helen. “Sei stato a pranzo da mia madre?”
“Non proprio,” rispose lui. “Mi sono fermato a salutare i tuoi genitori”. Sembrava una spiegazione più che sufficiente. “Mi dispiace terribilmente di arrivare in questo modo, ma sono gelato e mi chiedevo se mi avreste dato qualcosa da bere.”
“Molto volentieri,” rispose Helen, “ma non c’è più niente da bere in questa casa da quando Eric è stato operato, tre anni fa.”
Ned si domandò se stava perdendo la memoria, se quella sua capacità di rimuovere i fatti spiacevoli gli aveva fatto dimenticare che aveva venduto la casa, che le sue figlie erano in difficoltà, che quel suo amico era stato malato. Il suo sguardo si spostò dal volto di Eric al suo addome, dove vide tre pallide cicatrici suturate, due delle quali lunghe almeno una trentina di centimetri. L’ombelico era scomparso, e Neddy si domandò che sensazione avrebbe provato una mano nel toccare i propri attributi nel letto, alle tre del mattino, e nel sentire una pancia senza ombelico, senza legami con la nascita, un’interruzione nella successione della specie?
“Sono sicura però che troverai da bere in casa dei Biswanger,” soggiunse Helen. “Stanno facendo un gran baccano, si può sentirlo anche da qui, ascolta!”
Helen sollevò una mano, e al di là della strada, dei prati, dei giardini, dei boschi, dei campi, Ned udì di nuovo il suono squillante delle voci sull’acqua. “Be’, farò un bagno,” disse, sentendosi ancora vincolato alla scelta del suo percorso. Si tuffò nell’acqua fredda della piscina dei Sachs, e annaspando, correndo il rischio di annegare, riuscì ad attraversarla da un capo all’altro. “Lucinda e io abbiamo un’enorme voglia di vedervi,” disse poi accomiatandosi, e voltando appena la testa, che era già rivolta verso la casa dei Biswanger. “Ci dispiace che sia passato tanto tempo, e sicuramente ci faremo sentire molto, molto presto.”
Attraversò alcuni campi, verso la casa dei Biswanger e i rumori della festa che venivano da là. Sarebbero stati onorati di offrirgli qualcosa da bere, ne sarebbero stati davvero felici. I Biswanger invitavano a cena lui e Lucinda quattro volte all’anno, con sei settimane d’anticipo, e ogni volta venivano snobbati, eppure continuavano a invitarli, incapaci di comprendere le rigide e antidemocratiche regole della loro società. Erano quel tipo di persone che durante i cocktail discutono di prezzi, che a cena si scambiano informazioni sul mercato, che raccontano barzellette sporche dopo cena all’insieme degli invitati d’ambo i sessi. Non appartenevano all’ambiente di Neddy, e non erano nemmeno compresi nell’elenco degli auguri di Natale di Lucinda. Ned si avviò verso la loro piscina con una sensazione d’indifferenza, di degnazione e anche un po’ d’imbarazzo, perché sembrava farsi buio, e quelle erano le giornate più lunghe dell’anno. La festa era molto rumorosa e affollata. Grace Biswanger era quel tipo di padrona di casa che invitava gente di tutti i tipi, l’optometrista, il veterinario, l’agente immobiliare o il dentista. Nessuno era nella piscina, e il crepuscolo che si rifletteva nell’acqua aveva un bagliore invernale. Poi Ned vide il bar e si avviò in quella direzione. Quando Grace Biswanger lo vide, si diresse verso di lui, ma non aveva l’espressione cordiale che lui aveva diritto di aspettarsi, bensì un’aria bellicosa.
“Ehi, in questa festa c’è proprio di tutto,” esclamò ad alta voce, “compresi quelli che violano i domicili privati.”
Non sarebbe mai riuscita, però, a mortificarlo pubblicamente, su questo non c’era dubbio, e Ned non batté ciglio. “Uno che viola i domicili privati,” domandò garbatamente, “si merita almeno qualcosa da bere?”
“Accomodati,” rispose lei. “Non sembra che fai molto caso agli inviti.”
Poi gli voltò le spalle per andare a raggiungere alcuni invitati, mentre Ned andava al bar a ordinare un whiskey. Il barista glielo servì, ma con fare sgarbato. Era un mondo, il suo, in cui i camerieri tenevano un aggiornato registro sociale, e quell’umiliazione da parte di un barista affittato significava uno scadimento del suo rango sociale. Ma forse quell’uomo era nuovo dell’ambiente e non era ben informato. Poi Ned udì Grace che diceva alle sue spalle: “Sono andati in bancarotta da un giorno all’altro, ora non hanno altro che il reddito, e lui è arrivato qui una domenica, ubriaco, e ci ha chiesto di prestargli cinquemila dollari…” Era una donna che parlava sempre di soldi, peggio di uno che mangia i piselli col coltello. Ned si tuffò nella piscina, l’attraversò a nuoto e poi se ne andò.
La successiva piscina del suo elenco, la terz’ultima, era quella di una sua ex amante, Shirley Adams. Se era stato maltrattato a casa dei Biswanger, lì Ned avrebbe trovato consolazione. L’amore, anzi l’esaltazione dei sensi, sarebbe stato il miglior elisir, l’analgesico, la pillola colorata che avrebbe restituito elasticità ai suoi movimenti e gioia al suo cuore. Avevano avuto una relazione la settimana prima, o forse un anno prima, lui non ricordava bene.
Era stato lui a troncarla, il coltello dalla parte del manico l’aveva lui, e mentre varcava il cancello del muro di recinzione della piscina sentiva dentro di sé soltanto una grande sicurezza. Sembrava, in un certo senso, che quella piscina gli appartenesse, perché gli amanti, in particolare gli amanti clandestini, posseggono le cose dei loro spasimanti con un’autorità che è sconosciuta nel sacro vincolo del matrimonio. Shirley era lì, con i suoi capelli color rame, ma la sua figura, ai bordi della lucente acqua cerulea, non suscitava in lui profondi ricordi. Era stata una faccenda superficiale, ricordava Ned, anche se lei aveva pianto quando lui l’aveva troncata. Sembrò sconcertata, nel vederlo, e lui si domandò se era ancora offesa. Dio non voglia, si sarebbe messa a piangere di nuovo?
“Che cosa vuoi?” gli domandò.
“Sto attraversando a nuoto la contea,” le spiegò lui. “Oh, Cristo. Ma tu non crescerai mai?”
“Be’, che cosa ti prende?”
“Se sei venuto per soldi,” rispose lei, “non ti darò nemmeno un altro centesimo.” “Potresti darmi qualcosa da bere.”
“Potrei, ma non voglio. Non sono sola.” “Be’, passavo solo di qui.”
Si tuffò nella piscina e l’attraversò a nuoto, ma quando tentò di issarsi sul bordo, si accorse che non aveva più forza nelle braccia e nelle spalle, e pian piano raggiunse la scaletta e la salì.
Voltandosi a guardare dietro di sé, vide un giovanotto nello spogliatoio illuminato. E mentre attraversava il prato già buio sentì nell’aria l’odore di crisantemi o delle calendule, qualche persistente odore autunnale, penetrante come quello del gas. Alzando lo sguardo, vide che le stelle erano già spuntate, ma perché gli sembrava di vedere Andromeda, Cefeo e Cassiopea? Dov’erano finite le costellazioni di mezza estate? E allora gli venne da piangere. Era forse la prima volta che piangeva, nella sua vita di adulto, e sicuramente era la prima che si sentiva così infelice, infreddolito, stanco e sgomento. Non riusciva a comprendere la maleducazione del barista, né i modi sgarbati di un’amante che era andata da lui in ginocchio, bagnandogli i pantaloni delle sue lacrime. Ecco di che cosa aveva bisogno, di qualcosa da bere, di compagnia, e di vestiti puliti e asciutti, ma anche se sarebbe potuto arrivare direttamente a casa sua tagliando la strada, si diresse invece verso la piscina dei Gilmartin. E qui, per la prima volta in vita sua, non si tuffò in acqua, ma scese la scaletta nell’acqua gelida, e con le lente bracciate laterali che aveva imparato da principiante, nuotò attraverso la piscina. Poi si trascinò barcollando fino alla casa dei Clyde, e percorse anche la loro piscina, fermandosi continuamente a riposare con la mano sul bordo.
Quando salì la scaletta, si domandò se ce l’avrebbe fatta a ritornare a casa. Aveva fatto quello che si era proposto, aveva attraversato a nuoto la contea, ma ora era così inebetito dallo sforzo che il suo
trionfo gli appariva senza senso. Curvo, aggrappandosi ai paletti del cancello per sostenersi, imboccò finalmente il vialetto che conduceva a casa sua.
Trovò la casa immersa nel buio. Era così tardi che erano andati tutti a letto? Forse Lucinda si era fermata a cena a casa dei Westerhazy? E le ragazze l’avevano raggiunta lì o erano andate in qualche altro posto? Non erano d’accordo di rifiutare la domenica tutti gli inviti per rimanere a casa? Provò ad aprire le porte del garage per vedere quali auto erano dentro, ma le porte erano chiuse a chiave, e sulle mani gli rimase la ruggine delle maniglie. Mentre andava verso la porta di casa, vide che la violenza del temporale aveva strappato un tratto di grondaia, che ora pendeva sopra la porta come la bacchetta di un ombrello. L’avrebbe fatta aggiustare il mattino dopo. La casa era chiusa a chiave, e pensò che doveva averla chiusa qualche stupida cuoca o cameriera, finché non ricordò che già da un po’ di tempo non avevano più cuoche e cameriere. Gridò, batté con i pugni sulla porta, tentò di abbatterla a spallate, e poi, guardando attraverso le finestre, vide che la casa era disabitata.
Scopri di più da Giuseppe Genna
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
